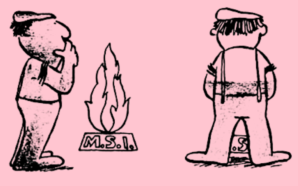Cosa rimane, dopo ottant’anni, dell’inizio della Resistenza al nazifascismo, in questo 8 settembre 2023?
E’ logico che, passato tanto tempo, rimanga ben poco di tangibile, di materiale, di corporalmente visibile: chi quasi un secolo fa ha lottato per liberare la nazione dalla doppia dittatura di Mussolini e del Terzo Reich, oggi resta nella memoria di moltissimi di noi. Il tempo non lascia scampo alla fisicità che è caduca, mentre il ricordo e lo studio di quello che avvenne dovrebbe vincere il logorio della quarta dimensione e oltrepassare le generazioni.
L’Ottantesimo della concretizzazione politica, organizzativa e militare dell’antifascismo nella Resistenza cade nel primo anno del governo Meloni. Primo e ultimo, c’è da augurarsi e, per fare in modo che sia così, nell’autunno che si avvicina c’è da lavorare tanto come opposizioni, entrando nelle più sottili contraddizioni prodotte dalle azioni scriteriate dell’esecutivo delle peggiori destre che abbiano mai governato questo povero Paese.
Quello che rimane dell’8 settembre 1943 è un lascito testamentario diventato tre anni dopo la Costituzione della nuova Repubblica nata sulle macerie del fascismo, sul nuovo Risorgimento prodotto dal movimento partigiani, da una assemblea di uomini e di (ancora poche) donne finalmente liberi di potersi esprimere, di potersi riunire e di poter ripristinare in Italia tutte quelle libertà che in età giolittiana erano, pur sempre, il minimo per una democrazia di stampo liberale e conservatore.
L’Italia di oggi quanto ha a che vedere con quella di ottant’anni fa? Se si fa un paragone meramente descrittivo, poco o nulla verrebbe da rispondere.
I mutamenti sociali e strutturalmente legati ad una economia rampantista e segnatamente liberista, sono tanti e tali da rendere quasi irriconoscibile il Paese che si è venuto formando dopo la fine dell’egemonia democristiana nei gangli più nascosti del potere istituzionale (e non solo), dopo il ventennio berlusconiano, dopo il tramonto della fiducia della gente nei confronti di una politica molto lontana dagli interessi sociali.
Appena finita la guerra, la ricostruzione impose un solidarismo diffuso che, tuttavia, fu ben lontano dal far sembrare l’interclassismo come nuovo criterio di unità di una Italia affratellatasi sotto le bandiere – pur molto diverse – dei partiti che componevano il Comitato di Liberazione Nazionale.
Era chiaro allora, molto, ma molto più di adesso, che l’orizzontalità dei problemi, la condivisione dei bisogni, la lotta degli uguali contro i vertici di una ricomposizione di classe che, in alto, molto in alto, veniva riprogettata a cominciare dagli affari e dalle speculazioni transoceaniche, stava alla base di una coscienza critica che chiunque poteva avvertire come fondamento culturale della nuova Italia antifascista, democratica e repubblicana.
La grande storia del movimento operaio, del sindacalismo veramente capace di interpretare le necessità fondamentali di un proletariato completamente escluso dai processi decisionali della ristrutturazione economica, del Partito Comunista Italiano ed anche del PSI, sono la prova di una rinascita italiana legata anzitutto alla coscienza per sé della classe delle lavoratrici e dei lavoratori. I grandi gruppi industriali si erano collusi con il mussolinismo tanto quanto la monarchia nel corso del ventennio fascista.
La fiducia nelle proposte di collaborazione tra mondo del lavoro e mondo delle imprese era crollata, ma resisteva ancora in quei settori in cui la Chiesa cattolica aveva stabilito un asse privilegiato con una conservazione che gli era necessaria per contrastare la minaccia dell’ateismo comunista e di una possibile rivoluzione che, col blocco sovietico alle spalle, veniva avvertita come una probabilità, nonostante la presenza americana sul suolo italiano.
Il crollo del multipolarismo, la fine dei blocchi della Guerra fredda, la rovina totale del sovietismo che era divenuto un capitalismo di Stato pachidermicamente sorretto da una burocrazia oppressiva e repressiva, hanno trasformato completamente la nuova storia del pianeta in una fase moderna in cui il capitalismo ha ritrovato quel significato di sé stesso che gli era stato contestato da una possibile alternativa di società, da un mondo nuovo fondato sulla pianificazione economica, sulla fine della proprietà privata dei mezzi di produzione, su esperimenti collettivisti quanto su progetti socialdemocratici.
L’Italia di oggi è anche il prodotto di una crisi globale tanto dell’economia quanto della politica e di una cultura che è stata rovesciata rispetto agli anni della costruzione di un senso comune della vita che si potesse ricercare esattamente nella condivisione di massa e, al contempo, nello sviluppo delle peculiarità singolare, di ciascuno di noi entro il patto costituzionale.
Spesso si paragona la semplicità del passato alla estrema complessità del presente, sostanzialmente per mettere in evidenza la distanza siderale che passa tra l’empatia popolare di un tempo, il reciproco riconoscimento dei medesimi interessi sociali da difendere con l’egoismo tutto moderno creato da un ricorso continuo alla competizione dentro la classe degli sfruttati, all’interno del mondo del lavoro, a tutto vantaggio dei profittatori, dei padroni del nuovo millennio che vengono cortesemente definiti “imprenditori“, per edulcorare un po’ la ferocia della funzione che posseggono.
Sono paragoni tutt’altro che impropri. Il liberismo, in quanto declinazione supersonica di una deregolamentazione dei mercati, affidati quasi esclusivamente all’andamento della borsa e dell’alta finanziarizzazione delle economie sia continentali sia intercontinentali, ha decostruito i rapporti sociali e ha atomizzato una società già parecchio frammentata nel corso degli ultimi due decenni del secolo scorso.
La spietatezza del racconto di una crisi economica come effetto di un eccesso di prudenza nei confronti dello stato-sociale, di oneri pubblici troppo alti, di un, quindi, necessario ricorso al privato per reggere l’urto della ciclicità di cortocircuitazioni economico-finanziarie che hanno avuto nel biennio 2008-2009 la loro massima espressione di pandemonico caos, ha creato nelle masse una nuova ideologia che si è sostituita a quella del pubblico e del benecomunismo.
Questa ideologia ha fatto e fa riferimento tutt’ora alle dinamiche di uno sfruttamento massivo della produzione che, a sua volta, è collegata imprescindibilmente ad uno sfruttamento altrettanto massivo delle fonti energetiche, delle terre, dei mari, degli oceani, dell’aria, di qualunque materia prima, nonché – ovviamente – della forza-lavoro.
Se con l’8 settembre 1943 l’Italia ha iniziato una nuova esistenza, volta a creare una società libera dei contorsionismi delle dittature che stritolano ogni iniziativa critica, ogni dubbio, ogni espressione della propria e della collettiva percezione tanto dei problemi quanto delle loro soluzioni, con il passare dei decenni la spinta iniziale di un rinnovamento sociale si è andata indebolendo.
Possiamo collocare la nascita del fenomeno liberista, più o meno nella seconda metà degli anni ’70. E’ a partire da quel periodo, dopo la grande rivoluzione culturale e sociale del biennio 1968-1969, che la borghesia si riorganizza e sceglie i suoi interlocutori politici di solido riferimento: il pentapartito diventa, nella sua prima definizione di “centrosinistra“, il garante di una stabilità che, smorzati i toni della seconda metà degli anni ’40 sui cosacchi che avrebbero fatto abbeverare i loro quadrupedi nelle fontane di San Pietro.
I tentativi olivettiani di una parziale condivisione della realtà produttiva con le maestranze, di un trattamento del lavoratore non solo come dipendente, bensì come parte anche decisionale del processo di costruzione della ricchezza (comunque sempre e soltanto privata), sono isolati nonostante ispirino una nuova vena critica nella sinistra moderata che rompe lo schema del completo asservimento dei socialisti al regime democristiano.
Le radici della Resistenza si fanno evidenti quando la Repubblica deve affrontare il pericolo della messa da parte della democrazia nel nome della necessità di una guida energica, forte e risoluta alla testa del Paese.
I colpi di Stato ipotizzati, studiati, tentati e rientrati nel giro di una notte, la “strategia della tensione” con le tante bombe messe nelle piazze, sui treni, dove si tengono comizi sindacali, mostrano il ventre molle in cui languono le istituzioni, prigioniere di una compromissione permanente con una classe dirigente che non vuole riconoscere nessun altro diritto ai lavoratori.
Sembra lo schema che si ripropone oggi: costretti a lottare per una diminuzione delle diseguaglianze sociali (e civili) proponendo un aumento dei salari che, nella cornice della magnificenza europeistica di una economia sviluppista ma tutt’altro che sviluppata, rimangono – come si sente spesso realisticamente, dati alla mano, dire – “al palo“.
Ma la povertà di oggi, quella di un mondo economico in cui regna il profitto proprio come nel 1943, quella di una società che subisce tutti gli effetti di una guerra in Europa devastante in cui si fronteggiano nuovamente due blocchi contrapposti, due imperialismi, sulla pelle dei popoli, non interrotta da un qualche decennio di ripresa generale. Non c’è nessuna ricostruzione all’orizzonte, ma solo scenari di devastazione ambientale, sociale, civile e morale.
La povertà culturale che accompagna tutto questo è degna dei cambiamenti intercorsi.
Il governo Meloni solo a parole dice di voler affrontare il diffuso disagio delle giovani generazioni, che sfogano i loro istinti nell’estremizzazione dei desideri, trasformandoli in atteggiamenti proprietari delle menti e dei corpi altrui, sminuendo intimamente le proprie coscienze, alienandosi oltre ogni immaginabile misura.
Ma, onorando la peggiore cultura repressiva di destra, fa quello che la destra deve fare: reprimere, vietare, predisporre celle, sbarre, controlli e non investe un centesimo nella riqualificazione scolastica, nel recupero vero di un sottoproletariato moderno lasciato a marcire nelle periferie da troppi decenni.
La recrudescenza neofascista è sostenuta da un clima ispirato anche dall’azione di governo e dal pregresso politico che c’è dietro quelle formazioni che portano la fiamma tricolore come emblema di un legame con un partito che è sempre stato fuori dall’arco costituzionale e dal patto fondante la Repubblica.
La violenza che si rende evidente nei tanti fatti in cui a subirla sono i più deboli, i fragili, le minoranze etniche, le persone LGBTQIA+, le donne, sta divenendo la cifra regolatrice di una a-socialità dentro la società stessa. Venendo meno la matrice originaria della condivisione della difficoltà, della estrema depressione postbellica, della distruzione materiale delle città, la sola memoria non è sufficiente – anche se necessarissima – a preservare l’interezza della Costituzione.
I rigurgiti di odio che vengono vissuti come “normalità” da chi li compie, fanno il paio con lo sdoganamento di tutta una serie di divieti morali che, pur non essendo scritti, venivano un tempo osservati. Non era solamente la Legge Scelba o quella scritta poi da Mancino a garantire il rispetto formale e sostanziale dei riti, delle interazioni reciproche, dando alla stigmatizzazione degli episodi di esaltazione del fascismo e del nazismo il ruolo che le compete di diritto.
E’ venuta meno una tensione generale, un comune sentire, una cultura di massa, una vera e propria egemonia culturale che la Carta del 1948, prima ancora che la sinistra, aveva stabilito come pietra angolare della comunità nazionale.
Se la domanda iniziale non ha una sola risposta possibile, non è detto che sia un male. Il problema è il contenuto della risposta, perché, almeno chi ha a cuore i valori laici, democratici, repubblicani e progressisti, si attenderebbe di sentirsi dire che, tutto sommato, nella claudicante ultrasettantennale vita della Repubblica Italiana, oggi quei valori sono al centro dell’agire istituzionale così come al centro della coscienza collettiva se non dell’intero, certamente della maggioranza del Paese.
Non è così. Anche se bisogna avere estrema cautela, rimanendo fedeli alla verità dei numeri e delle percentuali elettorali: Giorgia Meloni non rappresenta la maggioranza delle italiane e degli italiani, così come nessuna delle forze politiche intra ed extraparlamentari ha il monopolio di questa rappresentanza. Nessuno può affermare di essere il punto di riferimento di oltre la metà della popolazione.
Le elezioni europee del prossimo anno soppeseranno (quasi) proporzionalmente il valore numerico di ogni movimento e partito. Lì, senza il pretesto di accordi preventivi ai fini di governare l’Italia con premi di maggioranza truffaldini rispetto all’equipollenza del voto, e considerato ovviamente il dramma della disaffezione alla partecipazione al voto, sapremo quanto contano veramente le forze attuali. Non c’è dubbio che la destra, nella sua interezza, sia molto vicina a quella metà dell’elettorato che si esprime nella delega popolare verso i propri rappresentanti.
Non c’è dubbio che una parte dell’opposizione sia più incline a condividere certe scelte meloniane rispetto ad un linea alternativa senza troppi se e senza troppi ma. Non c’è altresì dubbio che quel che rimane dell’opposizione invece di difendere i ceti più deboli, a partire dal mondo del lavoro e della precarietà, del non lavoro e della disoccupazione di lungo termine, cerchi ancora una volta il compromesso con la logica imprenditoriale, per non inimicarsi troppo l’Europa e chi la guida.
Cosa resta dunque dell’atto di nascita della Resistenza, di quell’8 settembre 1943, seguito ad un 25 luglio in cui il crollo del regime fu verticale e poté resuscitare soltanto grazie alle colonne armate inviate da Hitler dal Brennero? Resta la possibilità di riaprire un varco nella memoria, ritrovare lo “spirito della Resistenza” di cui parlava Giuliano Montaldo. Uno spirito che è, anzitutto, libertà nella giustizia sociale e viceversa. Uno spirito che è nella Costituzione. Uno spirito che non alberga di certo in chi, oggi, regge le sorti di questo Paese.
MARCO SFERINI
8 settembre 2023
foto: screenshot