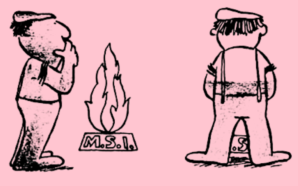La violenza come espressione quasi naturale di una brutalità primitiva umana (e quindi rientrante nell’animalità umana) che si fa strada nella coscienza di tante persone che risolvono così i problemi personali, le inquietudini interiori e i drammi quotidiani dentro un contesto preparato di sopraffazione che affonda le sue radici nel pregiudizio, nella catalogazione patriarcale, xenofoba e fortemente classista di una società spinta dal liberismo più sfrenato.
Uomini che uccidono le donne, ragazzi che uccidono altri ragazzi, poliziotti che sparano con una certa sistematicità a chi gli è lontano per origine etnica, per cultura, per semplice tratto empatico.
Comunque si guardino tutti questi episodi, disgiunti tra loro, da paese a paese, da Stato a Stato, il filo nero che li tiene uniti è una violenza molto più generale, sovraintendente tanto la sovrastruttura sociale, politica e culturale quanto quella economica.
Anzi, proprio dalla terribile condizione di disagio sociale, che si riverbera su tante esistenze dal maltrattamento che subiscono miliardi di persone in tutto il mondo con lo sfruttamento del lavoro, con la diffusione a tutto spiano della condizione precaria di un’esistenza che è mera sopravvivenza, con vere e proprie situazioni di subordinazione dei diritti ai doveri, del debole al forte, per tradizione, per prevenzione pregiudiziale, per disciplina, per – addirittura – diritto di Stato, per legge, derivano una serie infinita di comportamenti che sottovalutiamo e minimizziamo.
Il ruolo della violenza nella società capitalista moderna fa parte di una complessità che si articola in ogni ambito della vita quotidiana e che pare ingestibile e ingovernabile.
Il giovane trapper, che si impasticca, che sogna di diventare un cantante e che uccide una coetanea a coltellate, la infila in un sacco e la mette impietosamente in un carrello della spesa, il tutto alla luce del giorno, mentre solo una scia di sangue diventa l’iconica immagina dell’orrore perpetrato; oppure la lite sfociata tra due diciottenni, anche questa finita a coltellate e con la morte di uno dei due, forse per la contesa tutta maschile su una ragazza; oppure ancora la morte del 17enne francese Nahel, freddato da un poliziotto senza che vi fosse alcun motivo per imbracciare un arma e sparare contro un giovane di origine algerina che tentava di scappare con l’auto…
Si tratta di episodi slegati fra loro, molto diversi, eppure tutti hanno a che fare con la violenza, la sopraffazione, il pregiudizio (anche razziale) e, ovviamente, la morte. Sentirsi in diritto di uccidere, premeditando in alcuni casi, sull’onda di una emotività che è esacerbata dai propri pregiudizi in altri casi, è quella facilità che non dovrebbe potersi concretizzare così istintivamente. Manca un freno inibitore che faccia riferimento ad una soglia da non oltrepassare.
E’ completamente assente in questi casi un rapporto delle persone con un codice etico, ed anche professionale nel caso del poliziotto francese, che faccia da sicura all’arma carica, al coltello che, impugnato, sta per scagliarsi contro il corpo della coetanea, all’ira davvero funesta di chi ha un problema e non trova altro modo per risolverlo se non ricorrendo alla violenza, all’omicidio.
La competitività esasperata dal liberismo, la voglia di arrivismo e di successo, unita al senso di superiorità di una civiltà occidentale che si ritiene da troppo tempo la conquistatrice del mondo nei secoli passati e, pertanto, la “civilizzatrice” del globo terraqueo, sono tutti quanti aspetti di un unica impostazione antisociale che ha individualizzato i comportamenti singoli e ne ha fatto degli eccessi di libertà, assolutizzando questo concetto e mostrando quindi una predilezione per chi ci riesce, per chi ce la fa, per chi ottiene visibilità e consensi.
Tutto, del resto, sull’onda dei social network si gioca proprio su questo: sui “likes“, sui “followers“, su quanto piaciamo e su quanti ammiratori, estimatori e seguaci abbiamo.
La competizione diventa, in questo modo, davvero connaturata all’istintività delle nuovissime generazioni, incapaci, al pari dei cosiddetti “boomer“, di relazionarsi con le diversità se non in chiave accessoria, negativizzando i rapporti interpersonali e mettendo delle barriere artefatte tra giovani e meno giovani, tra poveri e ricchi, tra maggioranze e minoranze, tra culture e culture.
La politica di destra, conservatrice, bigotta, reazionaria, nazionalista quanto basta per esprimere un opportunismo di pochissimo conto, è quella sovrastruttura che ispira i comportamenti di una parte della popolazione che si ispira a modelli esclusivisti: dall’esaltazione dell’autoctonia, del primato dell’italianità su tutto il resto, al respingimento di qualunque fattore sia estraneo alle caratteristiche fisiche, culturali, ideali e sociali che ci confanno.
Noi, in sostanza, siamo ciò che riconosciamo come identico o simile a noi stessi. Il resto assume i contorni di una estraneità che è allontanamento, ghettizzazione, guardingo sospetto, discriminazione, emarginazione.
La violenza diventa una conseguenza inevitabile nel momento in cui le contraddizioni evidenti di una disposizione antisociale di questo tipo si scontrano con l’evidenza dei fatti: che, ad esempio, i popoli migrano da sempre per cercare condizioni migliori di vita; che le guerre comportano un tasso di migrazione endemico; che la fame genera conflitti e spostamenti.
Nel momento in cui definiamo l’Occidente come modello di civiltà, gli neghiamo la capacità di dimostrarlo in termini di solidarietà umana, di condivisione di tutto ciò che è comune: dalla terra, all’acqua, dall’aria agli spazi dove poter vivere e cercare nuove opportunità.
La lotta di classe, invece che essere verticale, viene distratta da una orizzontalità dei problemi: non lo sfruttato, il povero contro lo sfruttatore e il ricco, bensì il povero contro un altro povero. I padroni la guerra se la fanno tramite l’intermediazione degli indici di borsa, con i dividendi aziendali…
Ma i poveri no, loro muoiono: l’indigenza li spinge a delinquere, a diventare dipendenti della criminalità organizzata che, ovvio, li sfrutta a modo suo e ne fa dei perfetti capri espiatori per attuare altre strette repressive, per creare i presupposti per politiche di destra tutte dedite alla militarizzazione dei territori, alla repressione del dissenso, alla circoscrizione dei grandi temi della sicurezza sociale in un recinto asfittico di securitarismo fine a sé stesso.
La destra fa la sua parte di rappresentanza della conservazione e del tradizionalismo come cardini fondanti del liberismo stesso: la saldatura tra pubblico e privato sta proprio nella disposizione naturale e ovvia a trattare il primo come base fondante dei privilegi del secondo.
E questi privilegi di classe vanno tutelati: a partire dalla difesa a tutto tondo degli elementi antropologici e sociologici che determinano uno spettro di concause a sostegno di una identità nazionale, popolare, etnica e pseudo-culturale che, unendosi alla sacralità della religione, forma la percezione comune.
La percezione, quindi la sensazione, al posto dell’obiettività, dell’oggettivo, della concatenazione degli eventi, dei fatti. Ci si deve fermare alla superficie degli accadimenti, allo strillonismo televisivo, al dare sulla voce, alla violenza verbale che ispira soltanto contrapposizione e non dialogo, prevaricazione e non ricerca comune delle soluzioni.
La contesa che il liberismo trascina con sé è totalizzante e non risparmia niente e nessuno.
Si comincia da bambini, su incitamento dei genitori che vogliono i figli primi in ogni gara, in ogni scuola, in ogni momento della giornata e si continua con la formazione di adolescenti che non si percepiscono come esseri sociali, ma come tanti singoli, tante unicità distinte. Il vecchio “gruppo del sabato sera” diventa sempre di più un “branco” che cerca le sue prede e che vuole qualcosa da possedere. Per realizzare il significato che si è dato attraverso una società della proprietà privata.
E’ ovvio: ci riferiamo ad un particolare tratto distintivo che va inasprendosi, peggiorando, tanto quanto la violenza si diffonde e si salda con l’autoritarismo delle istituzioni o con la spregiudicatezza del rampantismo. Non solo giovanile, ma indubbiamente in maggioranza tale.
Non ci sono molti esempi virtuosi che spostino l’attenzione dalla competizione alla condivisione, dal primeggiare all’arrivare insieme. Ci prova un po’ la Chiesa di Francesco e, ogni tanto, ci riesce. Ci provano altre comunità di base, associazioni di volontariato e di solidarietà umana e animale. Ci provano l’ARCI, l’ANPI, Libera, Emergency, i sindacati e le grandi vecchie organizzazioni eredi di un Paese nel Paese, di una sinistra ormai dispersa in troppi rivoli e incapace di leggersi nel passato guardando ad un futuro prossimo con una lungimiranza adeguata ad una aggiornata critica del capitalismo.
La moderazione del progressismo incede come se fosse la via di un percorso mai sperimentato: sappiamo dove conduce il compromesso socialdemocratico-liberale e, allo stesso tempo, sappiamo dove ci porta il settarismo ottundente di chi ritiene di poter fare a meno di tutti gli altri nel processo di trasformazione della società.
La sinistra che va rimessa in piedi deve tenere conto anzitutto di queste mutazioni della società che sono il frutto di una involuzione del liberismo: pochi Stati tentano la strada dell’alternativa. Poche politiche di governo cercano di spostare l’asse degli interventi economici dal privato al pubblico.
Quasi nessuno ha in mente un orizzonte di alternativa sociale al dominio del capitale. Si provano ad individuare dei compatibilismi come ennesimo tentativo di un equilibrismo ultracircense tra classi dominanti e sfruttati, tra ricchezza estrema ed estremissima povertà.
Il disagio sociale che esplode con la violenza giovanile, con i femminicidi, con le discriminazioni sessuali, con la repressione poliziesca e con la rivolta delle banlieue è senza ombra di dubbio una commistione di fattori negativi che convergono, divergono pure, ma che sono perfettamente inseriti in questo modello di sviluppo egoistico, prevaricatore, omicida e criminale: distrugge le vite della maggioranza delle persone, assassina miliardi di animali ogni anno, devasta l’ambiente e non ha nessun freno morale ed etico.
Non può avere scrupoli. Non stiamo parlando di un entità a cui rivolgersi perché sviluppi una certa coscienza. Segue un corso che gli è dato dalla maggioranza degli individui e che lavorano incontro ai suoi dettami che si sono sempre più radicalizzati nel corso dei secoli. Per mettere un freno e poi la fine a tutto questo occorre un lavoro globale che non ci possiamo attendere dai governi e dalle grandi organizzazioni internazionali a presidio della stabilità politica ed economico-finanziaria del globo.
La storia nuova devono farla le masse, devono rifarla i popoli. Con ogni mezzo a loro disposizione: dalla resistenza nonviolenta attiva alla resistenza operaia, sindacale, politica, sociale e civile. L’unica violenza non biasimabile è quella che mette fine alla prepotenza delle classi padronali, dei profittatori e degli sfruttatori. L’unico odio ammissibile è quello di classe. La lotta deve tornare ad essere verticale, dal basso contro l’alto. Ogni orizzontalità è soltanto un favore al liberismo e alle destre (ed anche a quelle sinistre) che gli fanno da gentili servitrici.
MARCO SFERINI
30 giugno 2023
foto: screenshot