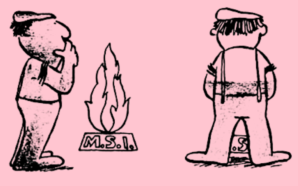Il livello di rappresentatività odierna della classe dirigente italiana, quindi della buona borghesia moderna, fatta di imprenditori medio-alti e di finanzieri e speculatori di varia risma, non è nemmeno paragonabile a quello che, nella così impropriamente detta “prima repubblica“, era praticato dalle forze del pentapartito, del vero, originale “centrosinistra“.
La Democrazia Cristiana ed il Partito Socialista Italiano, nelle rispettive differenze tanto ideologiche quanto più pragmaticamente riferibili alla contingenza dei loro tempi, in quanto soggetti politici di massa, storicamente presenti nella vita quotidiana della popolazione, erano stati rappresentativi di una vera maggioranza socialmente trasversale della popolazione.
Per quanto oggi si possa fare riferimento all’unità delle destre che sono al governo del Paese, soprattutto in questa dirittura d’arrivo della manovra finanziaria, si è potuto assistere ad un teatrino di posizioni tattiche che negano quasi aprioristicamente una strategia di gestione dell’interesse pubblico con oggettivissime ricadute negative anche sul fronte del privato.
Non esiste più, infatti, una separazione netta tra bene comune e bene davvero non comune, quindi verso quei privilegi che sono l’elemento distintivo della classe degli speculatori e degli sfruttatori. Così come non esiste più una distinguibilità precisa tra forze progressiste, di centro e di destra. La mistificazione dei confini della geopolitica italiana è, come è abbastanza noto, figlia di una desertificazione delle ideologie, anatemizzate come il male primordiale di una democrazia che andava liberata da questa presunta schiavitù.
DC e PSI, nella stagione della prima repubblica, insieme ad altre grandi forze politiche e sociali come il Partito Comunista Italiano, ed anche quelle di ambiti culturali della nuova sinistra o del liberalismo moderato, del repubblicanesimo laico e della socialdemocrazia, erano invece i bastioni di una visione ampia – il che non significa aperta ad una modernità dei diritti (e dei doveri) che incedeva sulla spinta delle lotte di massa – che considerava lo Stato alle dipendenze del cittadino.
Il ruolo pubblico era tenuto in debita considerazione, con tutte le storture e le traslitterazioni di un linguaggio costituzionale differentemente interpretato e, spesso e volentieri, costretto ad una resilienza nei confronti degli interessi particolari di questo o quel leader politico.
La destra meloniana, che comprende un ventennio di accumulazioni originarie di frammentazioni di estremismi e di avanzate e ritirate di populismi di vario titolo e natura, si muove invece soltanto su un piano di correlazione diretta con un interesse di classe che tiene conto non dell’interezza delle problematiche del Paese, e quindi della popolazione, ma solamente della parte più ricca e benestante.
Sia essa quella confindustriale e affaristico-borsistica, sia essa quella geograficamente inquadrabile nel nord/nord-est.
La presentazione della controriforma costituzionale sul premierato assoluto, sulla centralizzazione del governo come potere dirimente, sovraordinato ad un Parlamento che ne sarebbe alle dipendenze e ad una Presidenza della Repubblica letteralmente svuotata delle sue prerogative di garanzia massima e di generazione dell’equipollenza tra le varie architetture istituzionali, è molto più di un campanello d’allarme.
Conoscevamo già da tempo le intenzioni di Meloni e dei suoi alleati sulla particolarizzazione regionalista portata avanti da Calderoli col suo progetto sull'”autonomia differenziata“.
Adesso, mentre il progetto di affossamento del parlamentarismo come fulcro portante della Repubblica avanza nella commissione senatoriale ad acta, ed è arrivato all’esame del settimo articolo su dieci, dopo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio è possibile esprimersi ancora più compiutamente nel merito.
Arlechinnizzazione pseudofederalistico-regionalista dell’Italia e riforma degli articoli 88, 92 e 94 della Costituzione, riescono ad essere, insieme, il combinato disposto per uno scardinamento sedizioso della democrazia repubblicana, dell’equidistanza e dell’equipollenza tra i tre poteri dello Stato.
Il pericolo è dato anche da un progressivo analfabetismo di ritorno su una educazione civica che è andata, anno dopo anno, legislatura dopo legislatura, consumandosi nella febbrile giaculatoria populista e fintamente nazionalista del primato dell’azione e della decisione su quello del confronto democratico parlamentare, del rispetto dell’opposizione proprio come parte integrante e costituente del compito stesso del governo di amministrare l’interesse del Paese.
Le ideologie saranno anche state dichiarate defunte, ma una resta certamente molto saldamente attaccata al suo scranno: quella che teorizza (e pratica) il restringimento della delega popolare mediante una fuorviante implementazione della stessa dando al corpo elettorale la possibilità di scegliersi il Presidente del Consiglio, o premier che dir si voglia.
L’elezione diretta del capo del governo è il primo, ma non certamente ultimo, passo di una involuzione presidenzialista per la Repubblica italiana.
Per ora si scrive nero su bianco che alla autonomia differenziata esasperata, divisiva, e classista tra regioni del nord che plaudono a Calderoli e praticamente l’intero sud che lo fischia sonoramente, si associ un bilanciamento fasullo tra periferia e centro, escludendo il Parlamento dal compito di legiferare secondo una completa autonomia e indipendenza di constatazione dei bisogni del Paese.
Sarà il governo a dare le carte. Il Presidente della Repubblica potrà soltanto assistere alla partita e, se i giocatori saranno d’accordo, sciogliere l’intero Parlamento e non soltanto più solo una delle due Camere. Non potrà più avere un ruolo di mediazione tra i poteri dello Stato, ma solo di correlazione formale, realizzando quella antica narrazione comune che vuole un po’ da sempre fare del Quirinale un mero spettatore nell’odeon istituzionale e politico.
Si realizzano così i più reconditi sogni missini dell’uomo (o della donna) forte al comando, con una precisa delega popolare che darebbe alla maggioranza prevalente nelle urne il premio di maggioranza per farla arrivare al 55% dei seggi parlamentari.
Tutto viene escogitato per rompere l’armonia costituzionale che mette sullo stesso piano i poteri dello Stato, rispettandone le diversità per forma e per sostanza, alterando in pratica quel difficile patto che ha consentito alla Repubblica di sopravviversi in tutti questi anni nonostante i tentativi eversivi di mutazione della sua originalità fondata sulla condivisione delle scelte di interesse generale, sociale, civile e morale, pur nella attribuzione delle singole specificità e, quindi, delle relative responsabilità delle alte cariche dello Stato.
Sarà molto più facile, così, vendere in pasto all’opinione pubblica, abilmente manovrata con campagne di stampa e di televisione, nonché con il tam tam internettiano di social, meme e quant’altro, la correlazione naturale tra azione di governo e legislazione, svuotando il Parlamento del principio di formazione delle Leggi medesime: la base dialettica tra maggioranza ed opposizione.
Camera e Senato, obbedienti ai numeri stabiliti da una legge elettorale che sarà fatta ad uopo, ratificheranno gli atti del governo, inaccessibili alle modifiche emendative dell’opposizione che non sarà quindi più riconoscibile in quanto tale, ma soltanto come “minoranza” politica nelle istituzioni e nel Paese.
Il legittimismo che le destre cercano è la concretizzazione di un potere autocratico, che deriva da sé stesso una volta che ha avuto il consenso popolare indotto a colpi di rappresentazione della maggioranza come dell’unica area politica capace di salvare le sorti dell’Italia immersa nell’incertezza europea e nel caos mondiale.
Il cammino della controriforma di Giorgia Meloni e delle sue destre sarà lungo ma, per i tempi della politica, anche piuttosto breve. Se si andrà a referendum popolare confermativo (quindi se, dati gli attuali rapporti di forza, ne farà plausibile richiesta un quinto dei parlamentari, piuttosto che cinque consigli regionali o mezzo milione di cittadini mediante raccolta di firme), si ingaggerà una lotta a tutto spiano.
Non potrà essere altrimenti, perché a questa controriforma, che si presenta come la madre di tutte le eversioni contro il sistema parlamentare e democratico, contro l’idea di repubblica che ci ha permesso di vivere in un Paese sufficientemente rispettoso del diritto di ciascuno e di tutti di potersi esprimere e di poter rivendicare i propri sacrosanti diritti sociali e civili, andrà opposto uno sbarramento veramente di unità nazionale e di salvezza civica.
Se l’Italia dovesse diventare quella che ha in mente Giorgia Meloni insieme ai suoi corifei, ci troveremmo ad una ungherizzazione del Paese, ad una orbanizzazione dei princìpi fondamentali garantiti dalla Carta del 1948: ad iniziare dalla tutela delle minoranze, delle differenze, delle autonomie locali che non sarebbero risparmiate dalla calderolizzazione dei presupposti regionalistici su cui sono governati i territori.
Mettete insieme l’anomalia tutta italiana (nel contesto europeo sicuramente) di una democrazia in cui il capo del governo viene eletto dal popolo e in cui, in pratica, ha il Parlamento dalla sua parte, dove il Capo dello Stato conserva soltanto poteri di rappresentanza e di delega subordinata alle decisioni dell’eletto/a, con una divisione tra nord e sud del Paese sulla base del prodotto interno lordo territoriale, e avrete un mix esplosivo di contraddizioni.
Contraddizioni sia istituzionali sia sociali. La claudicante democrazia che fino ad oggi abbiamo preservato, in un contesto internazionale di crisi multistrato, tra guerre, fenomeni migratori, giganteggiamenti di economie nuove contro vecchie, poli capitalistici dell’ovest contro l’est e viceversa, finirà per essere una pura formalità da esibire nei contesti esteri.
Si prepara quindi un confronto-scontro tra la preservazione del sistema parlamentare e delle autonomie regionali da un lato e la creazione di un ibrido a metà tra il semipresidenzialismo e il federalismo classista della Lega Nord delle origini, tutta padroncini del Nord-Est, nonostante la sua vocazione psesudo-sociale e popolare imperniata proprio sul concetto di sottrazione delle risorse da Roma, sul ladrocinio capitolino, sull’anti-casta ante litteram, ben prima che questa litania fosse ripresa dal grillismo.
Sarà una vera e propria prova di compattezza democratica, sociale, civile, civica e morale. Sarà una prova di amalgama tra posizioni politiche anche antitetiche ma che, necessariamente, dovranno trovare nel massimo comune denominatore della difesa della Repubblica dal tentativo di stravolgerla fin nella sua più genuina e naturale essenza (l’uguaglianza) il propellente per una iniezione di nuova fiducia da parte della popolazione nei confronti di istituzioni prima di tutto da tutelare e poi da riformare.
Ma non distruggendone i cardini e le ispirazioni primigenie. Attualizzando il messaggio costituzionale e facendo della politica sociale il primo punto all’ordine del giorno di una nuova stagione di cambiamenti. Per il momento concentriamoci sulla controriforma meloniana e sconfiggiamo anche questo disegno eversivo.
MARCO SFERINI
31 ottobre 2023
foto: screenshot tv