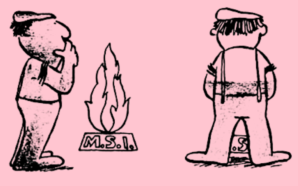Il richiamo alla pacificazione tra i contendenti suona ormai più come un appiglio meramente etico, persino pedante e dai toni un po’ snob. Invece, tutt’altro che retorico e imbolsito da una saccenteria moralistica, è il riferimento che la sinistra di alternativa deve alla pace come espressione morale, civile e materiale di una lotta che mira a criticare ben più a fondo la guerra rispetto alla superficie che ne emerge nei dibattiti televisivi e dalle pagine dei giornali.
Ovvio che qui ci si addentra in un terreno prettamente politico, per cui il biasimo dei conflitti non può essere solamente una ferma e ferrea indignazione per la plurimillenaria stupidità umana volta alla vicendevole autodistruzione (coinvolgendo, bene inteso, tutto il pianeta e tutti gli esseri viventi che lo abitano).
Si deve, invece, sollevare l’orpello che viene messo sopra ogni fatto che accade nella realtà in cui viviamo e che è un racconto “di classe“, una narrazione che evolve da una precisa connotazione di parte: quella di chi domina l’economia e, pertanto, ha interessi conclamati con i governi che, a loro volta, hanno tutto l’interesse a sostenere la struttura portante ed antisociale della società medesima.
Per questo la leziosità delle analisi che esulano dal contesto capitalistico e liberista, va lasciata a sé stessa: è un parlarsi addosso o, nel peggiore dei casi, un tentativo di distrazione di massa dalle vere problematiche che innescano conflitti come quello tra Russia, Ucraina e il più articolato e vasto “mondo occidentale“. La sragionevolezza di ogni guerra risiede, alla fine, sempre e soltanto in motivazioni che uniscono il potere politico al potere economico e viceversa.
Perché la sovrastruttura politica non solo dipende dalla struttura economica, ma ne è, per così dire, una conseguenza storicamente data dai rapporti di forza che si avvicendano nelle società e che ne determinano lo sviluppo, l’evoluzione. I criteri morali con cui si attribuiscono a questi mutamenti caratteri di positività o negatività tanto per l’individuo quanto per la collettività sono lavoro per i politici di professione, per i cultori del diritto, per i mediatori tra rappresentati e rappresentanti.
Quei cosiddetti “rivoluzionari“, di cui oggi si sente molto la mancanza, dovrebbero invece, proprio a sinistra, essere l’esatto contrario della professionalità politico-istituzionale o dell’affidamento dei cambiamenti sociali ad un riformismo che si rinnova ma che mostra, in fin dei conti, sempre lo stesso volto ruffiano verso il potere padronale e finanziario.
La sinistra di alternativa, i neo-comunisti moderni, libertari, che sono sopravvissuti all’inquinamento stalinista dei valori sovversivi dell’eguaglianza di provenienza giacobina e illuminista, hanno oggi il compito di dire NO alla guerra supportando questa avversità con un rinnovamento culturale e, perché no, anche fortemente ideologico che prenda esempio anzitutto dalla storia del “mondo grande e terribile” di quel “secolo breve” che ci è di poco, davvero molto poco, alle spalle.
Il Novecento, nei suoi primi tre decenni, è descritto a questi propositi dagli studi leninisti sul rapporto tra socialismo e Stato, da quelli luxemburghiani nel raffronto tra Stati dominanti e colonialismo in espansione globale, e dalle analisi gramsciane che riprendono, ampliano e suggeriscono una particolare attenzione alle saldature tra borghesia e fascismo, ai blocchi egemoni e alle masse inermi davanti al “sovversivismo delle classi dirigenti“.
Le guerre sono oggetto di acute riflessioni di Lenin, Luxemburg e Gramsci, proprio perché sono parte fondante del nuovo disordine mondiale capitalistico che investe Russia, Germania, Italia, che abbraccia l’Europa e l’intero mondo scoprendo per la prima volta che la guerra non riguarda soltanto più due o tre Stati che si fronteggiano per acquisire il dominio di questa o quella regione in odore di revanchismo nazionalistico.
La guerra, che non è mai veramente stata una “eccezione” nel corso del cammino umano, nel Novecento diviene fenomeno veramente costituente, quasi un passaggio obbligato per un imperialismo che altrimenti non ha occasione continua di perpetuarsi e spalancare le porte dell’economia di mercato al fenomeno della globalizzazione.
La fine della guerra “classica“, un po’ romanticamente combattuta dai soldati di ventura e da quelli che volevano fondare nazioni millenariamente divise, invase e umiliate nonostante la loro grande storia con le radici fin nell’antica Roma o nella democrazia ellenica, è sancita dalla modernità economica, dalle scoperte scientifiche che, senza infamia ma pure senza lode, vengono messe al servizio dell’industria bellica.
Lo sviluppo degli armamenti viaggia di pari passo con le ultime esplorazioni continentali, quando sulle carte geografiche la toponomastica copre praticamente tutte quelle zone lasciate bianche, quegli “interni” di cui ancora a fine ‘800 si conosceva veramente molto poco. Armi e materie prime in abbondanza, tratte da sfruttamenti di giacimenti minerari e auriferi, aprono la strada alla neo-colonizzazione dell’Africa, a quella delle Americhe centrali e Latina, ad un’Asia che finisce con l’essere esplorata tutta dalla Siberia al Turkestan.
La guerra di oggi, minacciata alternatamente da Russia e Stati Uniti nei confronti di una Ucraina pronta ad entrare nella NATO, è esattamente il prodotto di un confronto economico-politico tanto quanto lo sono state tutte quelle del passato.
I moralismi, se non vengono tradotti in una pratica nonviolenta, di resistenza attiva come quella ghandiana, non sono utili nient’altro se non alle proprie incoscienze e diventano un supporto interessato soltanto alla costruzione di alibi personali che vogliono evitarci di prendere contatto con i tanti problemi della modernità liberista, con le contraddizioni di un mondo che non impara mai la lezione semplicemente perché è obbligato a studiarne una che lo porta a conclusioni esattamente opposte ai motivi per cui vivere in pace dovrebbe essere la normalità e la guerra l’eccezione nella vita umana.
La guerra serve, è necessaria al capitalismo: gli Stati la fanno perché si trovano in una contesa dinamica incostante, che si autoalimenta grazie alla concorrenza economica che, a sua volta, stabilisce tutte le regole per il mantenimento del potere politico.
Non accorgersi dell’inevitabilità delle guerre significa non rendersi conto di vivere in un sistema economico omicida e suicida per il pianeta intero. Le contraddizioni delle nostre vite non riguardano soltanto l’alternarsi del bene e del male ogni giorno, cui non sappiamo dare risposte se non affidandoci al sentimento religioso e alla fede in qualcosa o qualcuno di soprannaturale, ultraterreno e metafisicamente inconoscibile.
Prima di tutto, le contraddizioni cui siamo soggetti, trascendono l’etica, visto che non c’è una morale nelle relazioni economiche, nei rapporti di classe, ma solo un riferimento al mero interesse personale, alla sopravvivenza ad ogni costo dei privilegi acquisiti. La complessità capitalistica fa in modo di farci apparire “naturale” ciò che invece è l’esatto contrario della natura e per la natura stessa.
Le guerre che noi esseri umani facciamo contro noi stessi sono combattute nel nome di una necessità di dominio che lega, come abbiamo visto, la sfera politica a quella economica: il nostro più che naturale e giustificabile istinto di sopravvivenza viene ridotto ad un confronto-scontro continuo per avere il “posto migliore” in questo pianeta e surclassare gli altri popoli, mortificando la naturalità di una essenza umana che non dovrebbe farci distinguere tra occidente e oriente, tra nord e sud, tra bianchi e neri, tra animali umani e animali non umani.
Invece, la lotta delle classi, nei millenni che abbiamo alle spalle, ha creato i presupposti – ormai già parecchio antichi – perché rimanessero a fronteggiarsi da un lato l’enorme massa degli sfruttati, dei lavoratori salariati, dei disoccupati e dei precari ultramoderni e, dall’altro, i detentori del potere economico, delle imprese, dei mercati finanziari, delle grandi concentrazioni di ricchezze ridotte nelle mani di un sempre minore gruppo di individui.
Gli Stati che si combattono oggi per il dominio geopolitico dell’Est Europeo, tutt’ora in Medio Oriente e ieri nelle rotte asiatiche delle nuove vie dei commerci, rispondono a questa regola aurea: la guerra deve sorprendere fino ad un certo punto, perché nel modello economico strutturale in cui sopravviviamo ogni giorno è un carattere paradossalmente vitale, endemico, fondante nell’alimentare altre situazioni che diano modo al capitalismo di rigenerarsi senza troppi inciampi in inconvenienti soluzioni di continuità.
Per questo non è possibile stare da una parte piuttosto che dall’altra: né con gli Stati Uniti e l’Ucraina e né con la Russia e i suoi alleati. Non c’è nessuna vittoria sociale, popolare nella guerra; non c’è nessuno sviluppo, nessuna evoluzione, nessun ampliamento della sfera dei diritti. Solo le rivoluzioni, che per loro natura hanno il compito di sovvertire gli ordini costituiti da tradizioni secolari e da incrostamenti economici altrettanto tali, possono essere l’unico tipo di violenza di massa ammissibile.
Purtroppo per fare una rivoluzione servono le condizioni sociali e i rapporti di forza tra le classi che oggi non si riscontrano praticamente in nessuna parte del mondo. La vittoria del liberismo, caso mai servisse una ulteriore prova, è proprio in quella guerra che sta per scoppiare alle porte di una Europa che è così imbarazzante nel suo essere politicamente entusiasta di sé stessa tanto quanto è invece irrilevante nel frapporsi tra i due poli che stanno per affrontarsi.
Non possiamo però rifugiarci in una analisi che, se non tradotta in una lotta politica, finisce con l’essere davvero astratta – benché oggettivamente tale e aderente alla realtà dei fatti. Abbiamo il dovere di costruire un grande movimento per la pace che sia quindi anticapitalista, antiliberista e che lo dica apertamente. Perché lottare per la pace vuol dire lottare contro le differenze di classe, contro tutti gli stereotipi e i pregiudizi che ne derivano e che imbrigliano le coscienze critiche e la dialettica (veramente rivoluzionaria) che ne consegue.
Tutto ciò che ferma la guerra è, per intenderci, un passo verso l’avanzamento delle rivendicazioni sociali, civili e umane che fanno progredire e non regredire l’intero pianeta. Ma non si può avere un sussulto di coscienza soltanto davanti all’autodistruzione tra noi umani.
Dobbiamo sviluppare questa indignazione ben al di là della guerra che ci facciamo dagli albori dell’umanità. Dobbiamo costruire una nuova consapevolezza del ruolo cui siamo chiamati con la nostra intelligenza: metterci al servizio di una rivoluzione sociale che capovolga tutto quello che oggi siamo abituati a considerare “normale“.
Senza questo rovesciamento complessivo, senza la messa in discussione del sistema economico capitalistico, le guerre si ripeteranno costantemente. Potremo anche indignarcene ma, per favore, almeno evitare ipocritamente di sorprendercene…
La vittoria del liberismo non ha i giorni contati ma, se questo modello incivile, disumano, devastante l’eco-sistema non sarà fermato e sovvertito, non avrà neppure molto altro tempo davanti a sé. E così l’umanità, gli incolpevoli animali non umani e una natura che, forse, per allora, avrà iniziato a ribellarsi alla mortificazione dell’intelligenza umana da parte della stupidità del profitto e dell’accumulazione dei capitali.
MARCO SFERINI
20 febbraio 2022
foto: screenshot