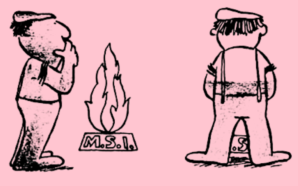Un tempo si diceva che solo la presenza di un nemico comune alimenta l’amor di patria. E lo si affermava per significare come un pericolo abbia la capacità di rinsaldare le fila, di eliminare le frapposizioni che si interpongono in uno stesso popolo, dentro una nazione. Un concetto militarista, bellicoso, tipico di quella inciviltà che concepisce la pace in funzione della guerra, il conflitto in relazione all’armonia intergenerazionale, interclassista e al di là dei confini sacri del paese in cui si vive.
Se l’armonia tra i popoli l’affidiamo molto semplicisticamente all’unità nel nome del Satana che di volta in volta può renderci amici nel tentativo di sopravvivere a questo o quel regime che vuole imporsi su altri, allora è fin troppo facile l’affermazione per cui è ben poca cosa l’umanità di per sé e nella prospettiva del futuro.
Ma è pur vero che, tanto per fare un esempio, gli Stati Uniti d’America hanno fondato la loro nascita nazionale sul nemico comune che, tuttavia, all’epoca della guerra d’indipendenza aveva almeno prodotto qualcosa di buono.
Una dichiarazione di uguaglianza di (quasi) tutti i cittadini (vedasi a proposito il quattordicesimo emendamento della Costituzione a stelle e strisce), un principio di novità democratica nel mondo conquistato dall’Europa e in cui il Vecchio continente iniziava a non essere più il solo a pretendere di dominare da est ad ovest, da nord a sud.
Poi, come è ancora più drammaticamente facile constatare nello studiare la storia di altri popoli e di altri passaggi epocali moderni, tra la solennità delle parole dette e scritte e la loro traduzione in una fattualità oggettiva, quotidianamente espressa nel concreto, ci passa non uno ma due, tre mari.
La Svizzera, per fare un altro esempio, nasce storicamente e leggendariamente come unità dei baliaggi che si opponevano alla dominazione asburgica. La confederazione è la sostanziazione di un atto di ribellione che fa della libertà di tutti e di ognuno il motto nazionale ricordato più come frase epica de “I tre moschettieri“: «Unus pro omnibus, omnes pro uno».
Ed è sempre il nemico comune a compattare, ad assottigliare le differenze e a rendere possibile quello che prima era considerato lontanissimo dall’inverabile. I processi di assimilazione, di unità che discende dalla constatazione della singola fragilità innanzi all’avversario potente, sono una costante nella Storia dell’umanità.
Si va, per l’appunto dalla costituzione di veri e propri Stati (come nel caso degli USA e dell’Elvezia) alla più repentina e meno impegnativa alleanza politico-militare che raramente si trasforma in un patto eterno, ma che viene stipulata a seconda delle circostanze.
Ciò non di meno, il punto dirimente rimane, se si prova a rimanere su un piano di analisi etico-politico-sociale, la povertà di un reciproco riconoscimento di diritti, di valori condivisi, di similitudine delle esistenze, di riscontro di elementi universali nella vita di tutte e tutti, l’incapacità di associarsi ed essere reciprocamente solidali se non in presenza di una disgrazia, di un evento traumatico, di una ostilità manifesta, di un pericolo.
Un altro celebre motto, che ci aiuta nella comprensione di questi tratti antropologici di una sociologia tanto antica (e atavica) quanto moderna (e per per niente sviluppista, ma molto rivolta al conservatorismo, al tradizionalismo), potrebbe essere: «In disgrazia addio orgoglio». Noi sapiens siamo portati a fraternizzare nel mal comune, per lenire le nostre sofferenze e cercare di attraversare le avversità mano nella mano. Dimenticando vecchi rancori, scavalcando ancestralissimi pregiudizi.
Ma, non appena vengono meno i presupposti che hanno consentito la disposizione provvisoria della verosimiglianza alla base del patto associativo, riprendono inevitabilmente campo i vecchi preconcetti che supportano gli interessi economici alla base di tutti i piani di geopolitica immaginabili. Ogni guerra obbedisce a questi saldi, demistificanti costrutti, a queste leggi non scritte, ma molto bene analizzate dagli storici e dagli antropologi del secolo scorso.
La guerra in Ucraina e quella che sta divampando nella Striscia di Gaza e in Israele non fanno di certo eccezione. Anzi, proprio l’aggiornamento del nuovo multipolarismo intercontinentale agli sviluppi della fase liberista di un capitalismo sempre più aggressivo, ha permesso di riconoscere nella composizione e scomposizione delle alleanze e dei campi in gioco una prova ennesima di quanto si scritto fino ad ora.
La teorizzazione, dalle ormai lontane elucubrazioni politico-finanziarie dei Chicago boys fino ai piani più recenti della CIA e delle amministrazioni americane che si sono succedute negli ultimi trent’anni, di un unipolarismo incontrastato, di un dominio mondiale pressoché incontrastato da parte degli Stati Uniti, pure insieme ai loro fedeli alleati nord-atlantici (europei), mediorientali ed asiatici, è crollata per effetto della globalizzazione stessa.
La diffusione su tutto il pianeta delle potenzialità (e delle grandi contraddizioni antisociali) del sistema dello sfruttamento delle risorse naturali (prima fra tutte quella della forza-lavoro umana e la trasformazione in merce di ogni essere vivente e della natura stessa…) e della produzione di profitti esponenziali a scapito di qualunque diritto umano, sociale e civile, ha generato una concorrenza inarrestabile.
La guerra, che per il tutto il Secolo breve aveva reso ancora più vero il motto di Carl von Clausewitz sulla prosecuzione della politica con altri mezzi, ha mantenuto il suo carattere eversivo, dirompente, lacerante e, al tempo stesso, unificante.
Perché, in un mondo così multipolarizzato, in cui è ben presto sparita la malevola illusione dell’unicità americana come sovraordinamento economico-politico, militare, etico e sociale in tutto e per tutto, il capitalismo non ha trovato altro modo per riequilibrarsi se non tramite una stagione di nuovi conflitti.
Guerre che vengono definite “regionali“, ma che, a ben vedere, hanno sempre più il tratto distintivo della separazione netta tra visioni antitetiche del mondo intero, dello sviluppo umano, del rapporto tra il potere e i popoli. Il modello democratico, che nella appena iniziata nuova guerra mediorientale sarebbe rappresentato dal teocraticismo israeliano e dai suoi metodi segregazionisti nei confronti dei palestinesi, viene messo sempre più spesso in discussione.
A farlo sono nuovi sodalizi tra politica e finanza in cui si stabiliscono dei tenui confini nel nome di un apparente rispetto di diritti umani che, al pari di molte democrazie che si autoincensano e si proclamano come esempio per il mondo, negano nei fatti la libertà di espressione, di parola, di critica, di diversità in tutte le declinazioni possibili ed immaginabili.
La guerra in Palestina è solamente il nuovo capitolo di una saga del cinismo più becero di poteri che si fronteggiano sulla pelle dei popoli.
La storicità del conflitto arabo-israeliano ce lo insegna: Israele è il cuneo dell’occidentalismo inserito in un panarabismo che ha provato a nascere nel corso della seconda metà del Novecento ma che, col pronto intervento della Repubblica stellata, è stato circoscritto entro un regionalismo sempre meno ambizioso, dipendente in un primo tempo dal sostegno sovietico e poi sempre più costretto ad ammiccare all’altra sponda dell’Oceano Atlantico.
L’attualità del conflitto israelo-palestinese, altresì, ci insegna molto di più perché si colloca in un mutatis mutandis in cui niente è veramente come pochi decenni fa e, se si fanno raffronti temporali ancora più ristretti, niente dal 7 ottobre è più come era fino al giorno precedente.
Il discorso di Biden sul riarmo ucraino ed israeliano (nonché sulla protezione gli USA intendono garantire al potenziale terzo fronte di Taiwan), sul sostegno pieno ed incondizionato da parte americana, prosegue una politica identica a quella del trumpismo.
L’imperialismo, la dominazione, il reputarsi sempre i gendarmi del mondo, i regolatori delle vicissitudini di interi popoli, di governi, delle loro stabilità o crisi economiche, dà alla questione palestinese un ruolo esiziale senza che essa voglia averlo e attribuisce ad Israele la comprimarietà delle azioni nel ristabilimento di un equilibrio mediorientale, così come fa dell’Ucraina il terreno di rimescolamento delle carte e di riconfigurazione dei confini della NATO in Europa.
Il dato forse più importante è quella metà del Partito democratico statunitense che è contrario all’invio di pacchetti di armi ad Israele. Almeno fino a che Tel Aviv non avrà dimostrato di svoltare dalla vendetta contro i palestinesi tout court ad una serie di mirate azioni militari contro Hamas.
Vista la terribile situazione che riguarda i civili nella Striscia di Gaza, riesce difficile oggi poter pensare che le forze di terra, di aria e del mare di Israele possano operare una netta distinzione, una separazione tra terroristi e popolo.
Se si leggono le dichiarazioni dei ministri del gabinetto di guerra, ci si convince dell’esatto contrario. Nessuna buona fede alberga nelle intenzioni manifeste di un esecutivo nato solo per spianare Gaza, raderla al suolo e annetterla almeno in parte allo Stato ebraico.
La politica che prosegue con altri mezzi. Eccola la guerra, che dovrebbe unire tutti gli israeliani contro il Satana Hamas (che Satana effettivamente è…), mentre la pace, la ricerca del dialogo e del compromesso finisce per essere divisiva.
Una contraddizione antietica, immorale, che però trascrive perfettamente i piani dei nemici: gli uni contro gli altri nel nome di un maggior potere che consolidi delle realtà statali, politiche e sociali in cui la religione diviene l’elemento primo che distingue tra superiorità etnica, storica, civile, morale. Il supporto pregiudiziale è imprescindibile se si vuole alimentare una specie di amor patrio che unisca al di là delle posizioni politiche e delle idee.
Di laicità, democrazia, rispetto, solidarietà, quasi nessuno parla. Si alza la voce di una schiera di premi nobel per chiedere almeno di risparmiare i bambini.
E i ragazzi. Si parla di quelli di Gaza, ma si parla anche di quelli di Israele. Si parla di quelli palestinesi, giovanissimi ragazzi gettati nelle carceri come se fossero dei pericolosi nemici per l’integrità nazionale dello Stato. Dov’è la radice popolare di Israele qui? Dove si trova l’umanità di una classe dirigente che dovrebbe rispetto alla propria storia?
Sono inutili questi richiami alla lezione del passato. La coazione a ripetere qui viene fatta rivivere ai palestinesi senza che nemmeno si possa invocare una sorta di spinta di un inconscio collettivo a far provare ad altri ciò che gli israeliani e gli ebrei di oggi, per fortuna, non hanno provato al pari dei loro nonni.
Ma la precarietà esistenziale di un popolo che vive sempre sulla linea dell’allerta massima e che ha, caso forse unico al mondo, un bunker per ogni abitazione, quindi una camera alternativa a quelle della vita normale, dove rifugiarsi in caso di attacco missilistico, è almeno un sintomo di una anomalia permanente, di un irrisolto problema tra Israele e il resto dei paesi arabi che lo circondano? Di sicuro oggi è un problema che riguarda almeno due formazioni: Hamas da un lato, Hezbollah dall’altro.
Israele può vantare molti amici nella sua lotta contro un annientamento che gli è stato giurato dall’Iran, dal jihadismo islamico, dalle formazioni più storicamente panarabe e antisemite. Ma anche Hamas può vantare una serie di amici che non disegnano di fare affari con gli Stati Uniti.
Il Qatar fra tutti. I fatti del 7 ottobre, più ancora, la strage dell’ospedale di al-Ahli sono la chiave di volta delle relazioni internazionali tra gli Stati arabi che fanno vacillare le alleanze fino ad ora strette con l’Occidente. Gli “Accordi di Abramo” sono quanto di più remoto si possa evocare oggi in tema di politica estera israeliana, saudita, sudanese…
Il nemico comune unisce, la pace comune separa, scinde, non amalgama perché l’obiettivo è tutt’altro. Nessuno degli attori tragici in campo vuole fermarsi. La guerra come igiene del mondo. La guerra come risoluzione dei conflitti. Un paradosso a circuito chiuso che viene accettato in quanto unica prospettiva possibile per l’eliminazione del nemico. Del nemico comune. La partita in corso è sempre mondiale.
L’illusione del conflitto regionale è buona solo per le diatribe televisive e per una minimizzazione dei pericoli enormi che tutti stiamo correndo. Per primi i palestinesi e gli israeliani. Per prime tutte le vittime di questo massacro.
MARCO SFERINI
21 ottobre 2023
foto: screenshot tv