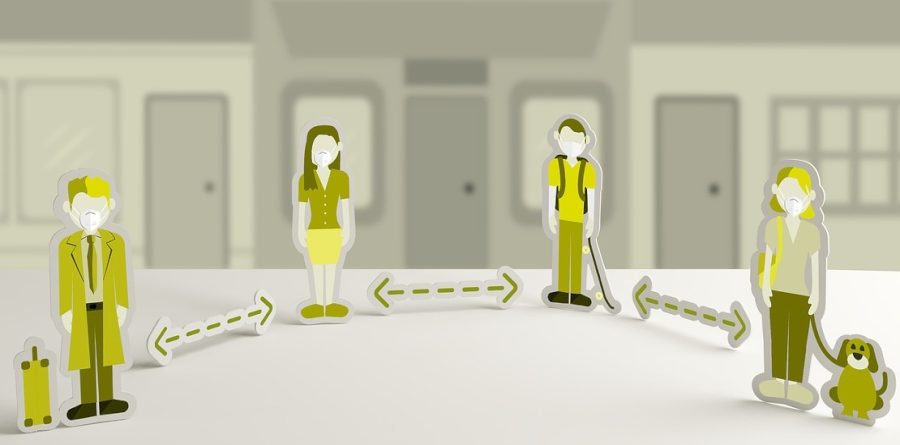C’è distanza e distanza: quella ai tempi del Coronavirus la declinano al maschile definendola “distanziamento sociale“. Ma s’è qualcosa che favorisce la socialità è proprio la vicinanza tra le persone, tra gli esseri viventi in generale.
Quando si mette una intercapedine, pur invisibile, tra i singoli, è poi proprio la società a venire meno. Una società piena di ingiustizie, di storture, di mancanze, di terrificanti contrasti fondati esclusivamente su pregiudizi e stigmi dettati da secolari, ancestrali disposizioni a considerare sempre superiore chi ci è simile e inferiore chi ci è dissimile per luogo di nascita, cultura, colore della pelle, credo religioso o adesione a questa o a quella metrica filosofica.
La distanza sociale è, dunque, un ossimoro cui ci siamo abituati in questi mesi di chiusura forzata di tutte le attività proprie della società capitalista: commerci, lavoro dipendente, sfruttamento dei migranti nei campi del Sud, velocissime pedalate dei riders per le vie delle grandi e piccole città per portare pizze, kebab, sushi a casa di ognuno di noi al primo squillo di telefono. Mancia compresa nel prezzo. Altrimenti che sfruttamento sarebbe mai?
Se il “distanziamento sociale” diviene un alibi per ampliare la forbice delle differenze e marcarle maggiormente, stigmatizzando mediante le fobie sociali tutta una serie di comportamenti nettamente antisociali, allora siamo davanti a qualcosa d’altro rispetto al concetto pessimamente espresso. Il distanziamento diviene esclusione, vilipendio delle specificità di ognuno, sguardo guardingo nei confronti sempre del diverso e attribuzione di caratteristiche di oggettiva “normalità” soltanto ad una autoctona rappresentazione di noi stessi che abbiamo tutti i diritti possibili: ius sanguinis, ius culturae, ius soli…
La bontà scientifico-sanitaria del distanziamento tra le persone va mantenuta nei limiti della necessaria protezione individuale (e quindi collettiva) dai rischi di contagio da Covid-19. Non può scadere nell'”allontanamento“, nell’accentuazione di prevenzioni veicolate dal solito razzismo che carsicamente passa nelle incoscienze di chi non riesce a comprendere (o non vuole farlo) l’intreccio di relazioni che l’esistenza ci pone innanzi e dalle quali è veramente “innaturale” tentare di sfuggire mediante protezionismi sovranisti di ogni tipo.
La distanza, infatti, può essere – come accade per i concetti che esprimono comportamenti vivibili dall’intera umanità e persino dal mondo animale, genericamente detto e inteso, e da quello vegetale (meno genericamente inteso) – di tanti tipi, proprio perché si uniforma da un lato alle tradizioni e alle abitudini dei popoli più differenti della Terra; dall’altro finisce per condizionarne proprio le più radicate convinzioni e determinare quindi la formulazione progressiva, lenta nel tempo, di una nuova sorta di “fenomenologia dello spirito“, proprio hegelianamente intesa, attraverso cui ogni individuo si eleva alla conoscenza, acquisisce nuove esperienze, le fa sue partendo da una base di latenza dei dati primordiali che ha sottomano.
Si tratta della formazione dell’abitudinarietà tutta umana, tipica nostra dunque, di adattamento allo sviluppo tanto della storia di intere comunità che data dall’epoca delle epoche: la distanza, in questo frangente, è un elemento distintivo che diventa essenziale per comprendere la cultura popolare.
Non solo come enunciato meramente filosofico, come concetto astratto dai contesti su cui si può dissertare quasi con una tendenza all’infinito: se e quanto si può stare distanti; da cosa si debba stare distanti o da chi; perché debba esistere una certa distanza dai pericoli, dai timori quotidiani che derivano – per l’appunto – da altri timori che alimentano una catena saldata dal collante rappresentato dalla stabilità del contesto pregiudiziale in cui si trova ad essere tesa e a separare ciò che si ritiene meritevole di tutela da ciò che si ritiene invece secondario, non propriamente appartenente a quel cerchio della fiducia, cinematograficamente ben reso in un film con Ben Stiller e Robert De Niro.
La distanza è, dunque, necessario capirla mediante l’osservazione oggettiva, trascendendo dalla fenomenologia hegeliana di uno spirito che nemmeno sappiamo se esiste: certo, se per “spirito” intendiamo un semplice riferimento alla coscienza umana, ad un’etica introiettata nel corso dello sviluppo della singola vita umana, allora che sia pure concesso parlare di “spiritualità“. Ma con cautela.
Tornando ai rapporti invece “materiali” tra gli individui, si può osservare come la distanza, al pari di tanti suoi simili concetti attribuibili all’intera vita sulla Terra, allo sviluppo delle relazioni sociali tra tutte le specie viventi, può assumere connotati di vicinanza, paradossalmente, quando è la determinazione di lontananze da pericoli imminenti: si deve riflettere in merito, escludendo il riferimento mentalmente automatico ad una “distanza fisica“, ma facendo semmai anche lo sforzo di pensare alla distanza come ad una forma mentis, ad una capacità di tenersi lontani da tentazioni che possono ledere proprio lo sviluppo di una nuova socialità e, quindi, di una nuova società.
Era solito ripetere Don Andrea Gallo: “Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei“. In questo caso, la distanza è espressione nettamente fisica, materialmente plastica, di un atteggiamento singolare che si traduce nella vita di ogni giorno e che genera un esclusivismo nei confronti di tutte e tutti coloro che riteniamo possano rappresentare un elemento di perturbazione della nostra sicurezza, della nostra serenità, della nostra capacità di riconoscerci per quel che siamo.
Tutto quello che mette in forse le nostre certezze, ci destabilizza e allora la distanza diventa un’ottima alleata per proteggerci dalle insicurezze, dai nemici cui dobbiamo necessariamente fare riferimento costante per sentirci uniti. Uniti nelle avversità. Almeno così si tuona nella ingombrante retorica delle tante ipocrisie che le destre spargono tra i ceti più popolari e sottoproletari per alimentare la disperazione e soffiare sul fuoco dell’instabilità sociale, garantendo così un maggiore controllo dei privilegi padronali, della ricattabilità dei lavoratori e dei precari nel complesso mondo di una economia pronta a crollare come un castello di carta davanti alla minaccia di un microscopico virus.
Tanta è la potenza dei batteri, dei virus, dei patogeni che possono annientare, come ci ha insegnato Wells, la peggiore invasione di mostri alieni, tanta è la fragilità di un sistema di sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano e di questo sulla natura e sugli animali.
La distanza antisociale dei tempi del Covid-19 è disarmante: rende incapaci in pochi mesi di fruire della capacità all’adattabilità a nuove forme di comunicazione, di apprendimento, di relazioni interpersonali che sono comunque compromesse in un prossimo futuro o, quanto meno, saranno ampiamente condizionate dal mutamento repentino che abbiamo vissuto dalla fine di febbraio ad oggi.
Nel giorno di inizio degli esami di maturità, la distanza possa rimanere solo fisica. Quei banchi dove siedono gli insegnanti, lontani almeno due metri dal posto dove siedono i ragazzi interrogati per un’ora su prove differenti preparate “a distanza” (si intende) sono una immagine piuttosto mesta di una limitazione della libertà che, per fortuna, la cultura può ridurre. Così come può eliminare tutte le distanze sociali che creano le barriere dell’ignoranza voluta, della mancanza di approfondimento su grandi temi di natura politica, di normalissima (e per questo per niente rassicurante) quotidianità dell’esistente.
Prima riusciremo ad archiviare l’ossimoro “distanziamento sociale” e prima torneremo non alla “normalità” ma alla prova di una ricostruzione della socialità fondata su valori che riconoscano nell’uguaglianza l’unica arma capace di abolire qualunque distanza tra gli esseri viventi. Abolire le distanze per fronteggiarsi nelle guerre, per costruire nuove altezze e nuove bassezze che si confrontano e ledono i più fondamentali diritti civili (e sociali), non è fare della vicinanza un valore. E’ mortificarne il senso proprio: vivere in comunità senza eliminare quelle necessarie differenze che sono il seme da cui nasce ogni dialettica evolutiva.
Senza confronto tra dissimili non vi sarebbe alcuna riconoscibilità per noi stessi. Per chiunque. La distanza, dunque, può soltanto avere la funzione di proteggerci da noi stessi: allontanandoci dai pregiudizi, dalle fobie antisociali, dalle paure recondite di un ciarpame anticulturale istillatoci dal sentito dire, dalle tante calunnie che soffiano come venticelli un po’ ovunque.
L’unica distanza buona è quella che crea vicinanza. Indirettamente. Ma la crea. Tutte le altre distanze sono negative. Anche quando ci proteggono da un virus. Dobbiamo saperle riconoscere e non attribuire loro alcun valore singolare e tanto meno sociale.
Questa è, oggi, una sfida forse più culturale, sociologica che pratica. Ma coinvolge la praticità dei rapporti che ogni giorno abbiamo. Pertanto non si può liquidare come speculazione o pontificazione, come sofismo o elucubrazione meramente filosofica. Riguarda la coscienza critica di ognuno di noi. Senza uno sviluppo in questo senso, sarà difficile far emergere tutte le buone intenzioni delle pubblicità che invitano a “ripartire“.
La retorica, come il pregiudizio, abbonda dove viene meno l’attenzione sulle complesse dinamiche sociali e dove tutto si risolve, alla fine, facendosi notare mangiando una ciliegia dopo l’altra mentre in una conferenza stampa si parla dei morti causati dal Coronavirus. Ecco, la distanza da prendere in questi frangenti, davvero, non è mai troppa.
MARCO SFERINI
17 giugno 2020
Foto di cromaconceptovisual da Pixabay