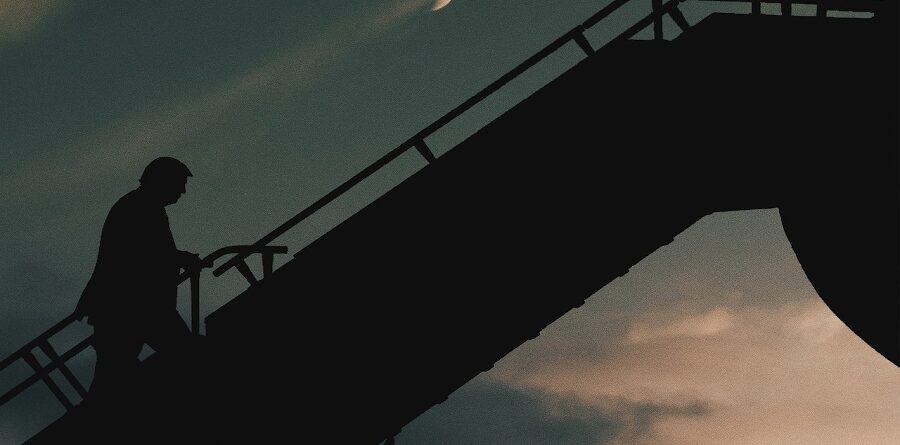Non è vero che il linguaggio non crea guasti o che le parole semplicemente volano nell’aere e si lasciano trasportare dal vento di un oblio che le allontana progressivamente dalle menti. Le parole restano, soprattutto se rappresentano o vogliono pretendere di rappresentare, come su una tela, le raffigurazioni contraffatte di questa o quella persona, tramutandola in un insieme di preconcetti che mai del tutto cessano di esistere, nemmeno davanti alla più evidente delle smentite, alla più palese delle verità provate.
La battaglia elettorale a colpi di parole è il minimo che si possa fare: la bellezza della politica trova una delle sue fondamentali espressioni proprio nelle capacità dialettiche, nei botta e risposta, nell’arguzia e nella sagacia, nella prontezza di replica, come se si fosse ad una partita di tennis e i concetti fossero palline che vanno da una parte all’altra della rete spinte dai colpi sinceri, retorici o infingardi dell’avversario.
Le presidenziali americane sono entrate proprio in questa fase, appena dopo la guarigione (o presunta tale…) di Donald Trump dal Covid-19. La veemenza degli attacchi contro Joe Biden ha oltrepassato ogni limite al gusto della battuta, alla ricerca anche nobile di un sarcasmo che stesse nei limiti di una pure originaria pratica anglosassone al rispetto del “competitor“.
Se Biden aveva definito Trump un “burattino nelle mani di Putin“, “un pagliaccio” e “la persona sbagliata al momento sbagliato” per quanto riguardava la pandemia del Covid-19, il presidente aveva risposto che Biden sostanzialmente era un cretino («Non c’è niente di intelligente in te») e che era ostaggio di quella sinistra radicale rappresentata dagli “antifa” tanto odiati dal sovranista che siede alla Casa Bianca.
La tensione era già abbastanza alta allora e si è andata inspessendo ulteriormente: per alcuni giorni Trump ha concentrato su sé stesso l’attenzione, attaccando i democratici indirettamente, magnificando la sua amministrazione come quella che, se messa in grado di proseguire nel mandato, libererà tutti gli americani dalle restrizioni dovute alla pandemia e riporterà la Repubblica a stelle e strisce ad una vita “normale“.
Nel glorificare il suo operato alla Casa Bianca, Trump non poteva non autoincensarsi e mostrare al popolo degli Stati Uniti d’America e al mondo intero come la sua guarigione dal Covid-19 avesse un qualcosa di miracoloso, fosse frutto di una potenza personale, quasi un ritorno di quel “trionfo della volontà” che finisce con l’essere indipendente da tutto e da tutti, persino dalla scienza medica.
Il cambio di strategia comunicativa di Trump, qualora qualcuno avesse ancora qualche dubbio, avviene definitivamente a Macon, in Georgia: scende dall’Aif Force One, raggiunge il palco con alle spalle la folla dei suoi sostenitori e inizia il suo attacco. Deve mostrarsi un superuomo, una specie di eroe nazionale per rimontare nei sondaggi: dalla BBC al Washington Post, dal New York Times alla Reuteurs/Ipsos, da Fox News alla Cnn e alla Abc News, un po’ tutti concordano su un distacco di circa dieci punti in percentuale. Biden attualmente prevarrebbe con il 52% dei consensi mentre Trump si fermerebbe al 42%.
Pertanto, in Georgia, sul palco fatidico di Macon, Trump attacca duramente Biden e contenuti e tono delle parole si alzano verticalmente, tralasciando l’allegro andante da operetta recitato nel dibattito televisivo del 30 settembre scorso. Deve poter esasperare gli animi degli americani, compressi in una sopravvivenza difficile tra crisi sanitaria e crisi economica. Per questo non fanno più presa sulla popolazione le descrizioni di un vicepresidente stanco, assonnato, debole non tanto per la vecchiaia quanto per la stigmatizzata lunga carriera politica in cui “non ha fatto niente“.
Il bersaglio rimane Biden. Anzi, un Biden: dal padre al figlio per colpire nuovamente il padre. Trump non ha mai smesso di essere un imprenditore misto ad uomo di spettacolo. Mai. Ma oggi conserva tutte queste peculiarità da “one show man” in una Casa Bianca però divenuta oggi il simbolo di un focolaio di coronavirus che spaventa l’America intera.
Sul piatto della bilancia del consenso popolare vengono messi i pesi maggiori: i colpi bassi. Quelli che non dovrebbero essere consentiti, ma che la disperazione fa usare per vincere un incontro che sembra segnato in parte dalla sua gestione governativa del Grande Paese e in buon parte dalla gestione sempre governativa dell’emergenza sanitaria che non termina oggi e non terminerà nemmeno il giorno del voto.
Trump lo sa e sa che il tempo gli è nemico: ne ha poco per rimontare nei sondaggi e nelle grazie popolari anche di quegli abitanti della Florida che gli assegnarono il primato su Hillary Clinton; non ne ha affatto se pensa di poter battere il Covid-19 proprio sul tempo: l’ondata lunga della pandemia andrà oltre il 2020, si prenderà anche tutto il 2021 e sarà un grattacapo per il nuovo come per il vecchio presidente.
Così, tempo per tempo, tempo nel tempo, tempo oltre il tempo, Trump viaggia nel passato e nel futuro, traversa un incerto presente e prova a mostrare come la cricca “criminale” (questa è la definizione letterale affibbiata alla famiglia Biden) che lo vuole spodestare dalla sala ovale abbia radici ben più lontane: la “timeline” di questo complotto risalirebbe persino al 2016, quando – a suo dire – persino Obama, naturalmente in combutta con Biden, avrebbe spiato la campagna elettorale repubblicana.
Il livello di scontro a parole è divenuto così alto da influenzare fortemente l’opinione pubblica, creando tutte le condizioni per una drammatica polarizzazione tanto dell’elettorato quanto della società, sempre più divisa tra estremisti di destra associati a liberisti altrettanto conservatori e liberal-liberisti democratici cui si affiancano i settori di una società americana che rivendica unitariamente diritti sociali e diritti civili.
Il tentato colpo di Stato in Michigan, col progettato rapimento della governatrice democratica ad opera di un gruppo di suprematisti bianchi, elementi di un neofascismo e neonazismo conclamato e per niente nascosto, dovrebbe suonare come un campanello di allarme per una società americana che ha bisogno di riforme sociali, di nuova attenzione verso quelle fasce di popolazione che guardano al trumpismo solo con gli occhi della disperazione e non con quelli della speranza.
Nell’ultimo anno, Trump si è sempre più spostato a destra, mostrandosi accondiscendente verso proprio le parole, il linguaggio, i concetti di gruppi che persino l’FBI considera eversivi, addirittura “terroristi” come i complottisti deliranti del QAnon, le cui credenze sul “deep state” e sulla “rabbit hole” (la tana del coniglio, laddove per tana si intende un substrato terrestre dove sarebbero segregati dallo “stato nascosto” milioni di bambini in preda ad un regime di pedofili mondiale) sono parzialmente condivise dal 16% degli americani (secondo un sondaggio dell’istituto Civiq) e, tra questi, da un 33% degli elettori repubblicani. Tra più o meno credenti alle follie del QAnon, si tratta di oltre 50 milioni di persone.
In questi cinquanta milioni di americani non vi sono soltanto persone prive di una difesa culturale, di un minimo di raziocinio e di capacità di discernere il vero dal falso, il fantasioso dal delirante. Purtroppo l’estremizzazione di destra non è l’unico serbatoio da cui questi teorici del complottismo mondiale attingono.
Il fatto che Trump non abbia voluto prendere le distanze dai cospirazionisti del QAnon, durante un dibattito televisivo sulla Nbc, è emblematico. Non direttamente, ma con la sottigliezza della calunnia, con il subdolo metodo del “non lo dico ma nemmeno lo nego“, si tende a far passare la teoria fantasiosa (eppure così diffusa) che i democratici sarebbero una sorta di setta di pedofili, dediti al satanismo, mentre la vittoria di Trump vorrebbe dire evitare di consegnare l’America la Bianconiglio moderno e alla sua tana dove imperversa ogni sorta di immoralità e di aberrazione nei rapporti sociali, tanto individuali quanto collettivi.
Le parole creano guasti. Quelle dette e anche quelle non dette: mezzi atteggiamenti e mezze parole sono più dannosi di uno sbraitare ai comizi contro Biden o delle accuse di criminalità sparse qua e là, senza prove: fango su fango.
L’America che va al voto è anche questo: una battaglia per parole di verità o, quanto meno, per parole che sempre più le si avvicinano. Il pericolo rappresentato dal trumpismo è un insieme di liberismo sfrenato, sovranismo autarchico, imperialismo esasperato e repressione di ogni idea sociale, di ogni tendenza all’egualitarismo basato sulle differenze e sull’umanità che le ispira e le permea.
Le parole sono importanti e men che meno in questo contesto vanno sottovalutate.
MARCO SFERINI
20 ottobre 2020
Foto di Alemko Coksa da Pixabay