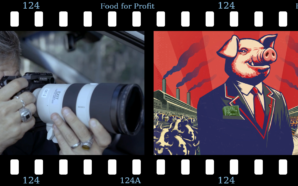SECONDA PARTE
Nella seconda metà degli anni venti del secolo scorso, Hollywood era in forte espansione, vennero istituiti gli Oscar, lanciato il “sonoro” e le “Major” americane si contendevano le “stelle”, spesso provenienti dall’Europa. La MGM in particolare aveva ingaggiato dalla Svezia, insieme al suo mentore Mauritz Stiller ben presto liquidato, la divina Greta Garbo. La rivale Paramount si mise così alla disperata ricerca di una Star da contrapporle. La trovò grazie ad uno dei suoi registi.

1. l’arrivo di Greta Garbo alla MGM portò la Paramount a cercarsi una diva da contrapporle
Josef von Sternberg, infatti, durante le riprese de L’angelo azzurro aveva invitato sul set berlinese il produttore americano Ben Percival Schulberg che capì subito le potenzialità di Marlene Dietrich. All’attrice, complici le interessate pressioni del regista, venne proposto un contratto di sette anni. Marlene prese tempo anche per motivi familiari, ma alla fine accettò dietro un compenso non banale: 500 dollari a settimana fino ad arrivare a 3500 per l’ultimo anno. Riuscì, inoltre, a far inserire, forse complice la precedente separazione artistica tra Garbo e Stiller, una clausola che prevedeva per la diva la scelta del regista, ovvero la scelta di lavorare sempre con von Sternberg, col quale aveva ovviamente iniziato una relazione.
Il 22 gennaio, appena terminata la lavorazione de L’angelo azzurro, il regista partì per gli Stati Uniti, senza nemmeno aspettare l’uscita del film e la firma della sua pupilla. Marlene per il viaggio gli regalò un piccolo romanzo del viennese Benno Vigny intitolato “Amy Jolly, die Frau aus Marrakesch” (“Amy Jolly, la donna di Marrakesh”) in cui una donna rinuncia a sposare un artista ricco e colto per stare con l’uomo che ama. Sembrava un addio. Non fu così. Marlene Dietrich partì per Hollywood il 2 aprile 1930, il giorno dopo la prima berlinese di Der blaue Engel. Salpò sola sul piroscafo “Bremen” lasciando in Germania il marito Rudolf e, soprattutto, la figlia Maria.
Sull’imbarcazione l’attrice conobbe Travis Banton stilista e costumista che contribuì a creare quello stile mascolino e anticonformista che caratterizzò Marlene. Durante il viaggio, infatti, Banton le scattò alcune foto in abiti maschili, da marinaio per la precisione. Scatti che oggi, benché bellissimi, potrebbero sembrare banali, ma all’epoca avevano qualcosa di scandaloso se non sovversivo: una donna coi pantaloni.
La diva giunse a New York il 9 aprile ad attenderla il contratto con la Paramount e Riza Royce. Chi era? L’inferocita moglie del fedifrago Josef von Sternberg che stringeva in mano due denunce, una per diffamazione, l’altra per circonvenzione di incapace. La casa di produzione cercò di mettere a tacere tutto. Aveva finalmente la sua diva, che presentò ai giornalisti direttamente sullo scalo facendola salire in cima alla pila di bagagli in abito nero e pelliccia di visone.

2. Marlene Dietrich divenne “La donna che perfino le donne possono adorare”
Un mito che la Paramount alimentò con una villa a Beverly Hills, una Rolls Royce, una serie infinita di ricevimenti e feste. Non solo. Se all’inizio la casa di produzione cercò di censurare e proibire le foto di Banton, poi le sfruttò. Marlene divenne “La donna che perfino le donne possono adorare”.
Dietrich, sensuale, ma troppo in carne per gli standard hollywoodiani, si mise a dieta. Le sue gambe divennero ancora più affusolate, il suo volto si sfinò (si scrisse per anni anche dell’estrazione dei molari, ricostruzione smentita duramente dalla diretta interessata), il trucco si fece più raffinato, le sopracciglia curate, i capelli sempre più biondi. Marlene, la diva peccaminosa e conturbante, contro Greta, la diva algida e misteriosa.
Ma di fatto sul grande schermo gli americani Marlene non l’avevano mai vista. L’angelo azzurro stava ottenendo sempre più successo in Europa, a Parigi venne aperto un locale in suo omaggio, ma negli USA, nonostante la versione in lingua inglese girata in contemporanea a quella tedesca, il film non era ancora uscito. La Paramount, infatti, prima di distribuirlo voleva realizzare una pellicola interamente hollywoodiana su cui von Sternberg stava già lavorando. Era un dramma tratto dal libro che Marlene gli aveva regalato per il viaggio, un film tratto da “Amy Jolly, die Frau aus Marrakesch”.
Per il cast vennero scritturati due star dell’epoca, l’emergente Gary Cooper e il consolidato Adolphe Menjou che nella realtà avevano in comune un fervente anticomunismo, nella finzione del film si contendevano l’amore di Amy Jolly, ovviamente interpretata da Marlene Dietrich. Sul set, ovviamente lontano dagli anticomunisti, fece una comparsa anche Sergej Ėjzenštejn in viaggio nelle Americhe. Il 14 novembre del 1930 uscì nelle sale Morocco (Marocco).

3. Marocco (1930) di Josef von Sternberg
Amy Jolly (Marlene Dietrich), una cantante di cabaret, giunge in una città del Marocco francese sede di un battaglione della Legione straniera. Al nightclub Lo Tinto riscuote grande successo con le sue canzoni, aiutata dalla benevolenza di un ricco pittore dilettante, La Bessière (Adolphe Menjou), che l’ha già notata sulla nave e le ha inutilmente offerto la sua protezione. Amy è, infatti, colpita da un semplice legionario, Tom Brown (Cary Grant), beniamino delle ragazze locali, nonché della moglie del comandante in campo Caesar (Ullrich Haupt). Quanto Tom va a trovare Amy, tra i due c’è subito attrazione che accende la gelosia di madame Caesar (Eve Southern). Tom riesce a sventare un attentato ordito dall’ex amante, ma si rifiuta di deporre in proposito davanti a Casear che, ben conscio del tradimento della moglie, si vendica mandando il giovane legionario in missione nel Sahara. Prima di partire per il deserto, Tom ipotizza di fuggire con Amy, ma cambia idea quando vede che la ragazza sfoggia i preziosi gioielli regalategli da La Bessière e pensa sia meglio per lei. La cantante accetta così la proposta di matrimonio del pittore, ma quando rincontra Tom, rientrato dopo una missione pericolosa e pronto a ripartire, segue il suo istinto, abbandona tutto, si toglie le scarpe e lo segue nel deserto.
Uno dei classici film hollywoodiani dell’epoca “antirealistici e stilizzati” (Mereghetti). Un dramma esotico, genere che diverrà uno dei marchi di Sternberg, con al centro un triangolo amoroso – la bella che sceglie tra un vecchio ricco e un giovane squattrinato – tema che ricorrerà nella filmografia dell’attrice. Ma Marocco fu importante soprattutto per definire l’immagine stessa di Marlene. Per prima cosa la fotografia curata da Lee Garmes che riuscì ad esaltare, e lo farà anche nei film successivi, il volto dell’attrice. Poi gli abiti maschili, il frac nero con cilindro in particolare. La sigaretta sempre accesa. E ancora. In Marocco ci fu il primo bacio tra due donne nella storia del cinema. Durante un’esibizione al nightclub, infatti, Amy Jolly in abiti maschili, bacia una spettatrice. La censura non scattò, siamo prima del codice Hayes, ma ci andammo vicini.

4. il primo scandaloso bacio tra due donne nella storia del cinema
Indimenticabili, infine, le scene in cui Amy Jolly canta “What am I bid for my apple”, offrendo gratis la sua mela al legionario Tom, e la sequenza finale, ripresa tra l’altro da Bernardo Bertolucci ne Il tè nel deserto.
Marocco, dalla sensualità meno esplicita rispetto a L’angelo azzurro, riscosse un grande successo di pubblico e ottenne quattro nomination all’Oscar, giunti alla quarta edizione, per regia, fotografia, scenografia (curata da Hans Dreier) e per la Miglior attrice protagonista. Non ne vinse uno. Per Marlene Dietrich fu la prima e unica candidatura. Otterrà riconoscimenti anche più importanti, ma non vinse mai l’Oscar. Una cosa per cui andava snobisticamente fiera definendo il premio “una delle più grandi truffe del secolo”. Che ci tenesse o meno è indifferente, aveva comunque vinto, il suo volto avvolto dal fumo era ormai entrato nell’immaginario collettivo.
Dopo l’uscita del primo film hollywoodiano della coppia Sternberg-Dietrich potè finalmente essere proiettato negli Stati Uniti anche il primo film in assoluto della coppia, col titolo internazionale The Blue Angel. Era il 5 dicembre 1930. La versione girata in lingua inglese era inferiore rispetto all’originale tedesca, la principale canzone “Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt”, ad esempio, passò da essere scandalosa “Dalla testa ai piedi fatta per l’amore” a romantica “Falling in love again” che recitava “Innamorarsi di nuovo. Non avrei mai voluto, che devo fare?”. Come se non bastasse il film fu tagliato passando dai 109 minuti originali ai 99 “made in USA” per mettere ulteriormente in evidenza il ruolo di Marlene, come aveva fatto la MGM, in modo ancor più marcato, col film che lanciò Greta Garbo, Gösta Berlings saga.

5. Greta Garbo divenne Mata Hari
Ma se in Europa il cinema era ancora un’arte, negli Stati Uniti era già un’industria. La MGM stava lavorando a Mata Hari con la rivale svedese, il film biografico sulla celebre spia-danzatrice, così la Paramount fece realizzare in grande velocità, a poche settimane dalla fine delle riprese di Marocco, una nuova pellicola all’attrice tedesca. Il regista era ovviamente von Sternberg, lasciato dalla moglie, che cercò di esaltare, quasi ossessivamente, il suo feticcio femminile. Era Dishonored (Disonorata).
Durante la Prima guerra mondiale, Marie Kolverer (Marlene Dietrich), una prostituta viennese cinica e disinvolta, viene ingaggiata come spia dal capo dei servizi segreti austriaci (Gustav von Seyffertitz). Col nome in codice X-27 la donna smaschera prima il generale traditore von Hindau (Warner Oland, futuro Charlie Chan) poi si mette sulle tracce del tenente Kranau (Victor McLaglen), una spia russa nota come H-14. Ma dopo averne favorito l’arresto, lo fa scappare, venendo condannata a morte per tradimento.
Un melodramma, che il regista avrebbe voluto chiamare X-27, in cui trovare una veridicità e una linearità storica è inutile, ma vedere Marlene Dietrich è impagabile. In fondo era quello, dichiarato, l’intento di von Sternberg. Indimenticabile una delle battute finali in cui, ormai condannata a morte, Marie chiede al prete la sua uniforme da prostituta o meglio “un abito di quando servivo i miei compatrioti e non la mia patria”.

6. Disonorata (1931) di Josef von Sternberg
Marlene Dietrich era ormai il prototipo della donna libera, emancipata, disinibita, disincantata e spregiudicata. Ma aveva in Germania una figlia che l’aspettava per Natale. Poteva una sex simbol avere una famiglia? Greta Garbo aveva una figlia (ovviamente no)? Come non danneggiare quell’immagine di femme fatale di fronte ad un pubblico che, ieri ben più di oggi, confondeva arte e vita, schermo e realtà? La Paramount decise così di attendere per la distribuzione di Disonorata che avvenne solo a partire dal 6 marzo 1931. Marlene alla prima non c’era, era andata a Berlino.
L’attrice, infatti, poco dopo la distribuzione di Marocco, nel dicembre 1930 era partita per l’Europa dove rimase fino all’aprile del 1931. Il 13 dicembre festeggiò il compleanno della figlia Maria, per poi ritrovare la mamma Wilhelmina, la sorella Elizabeth e il marito Rudolf che, già prima della partenza della moglie per Hollywood, aveva trovato serenità tra le braccia di un’amica di Marlene che si era presa amorevolmente cura della piccola Maria in sua assenza. Si chiamava Tamara Matul.
La trasferta nell’amata Berlino servì a Marlene anche per riabbracciare i vecchi amici del cabaret, primo tra tutti Friedrich Hollaender che le chiese di incidere alcune nuove canzoni. Due in particolare divennero parte del suo repertorio “Johnny” e “Wenn Ich mir was Wünschen Dürfte” (“Se potessi esprimere un desiderio”).

7. Friedrich Hollaender con la prima moglie Blandine Ebinger
Nel frattempo Marocco era stato distribuito anche in Germania e stava per uscire, in contemporanea con gli USA, Dishonored. Per pubblicizzare il nuovo film il nome Marlene, scritto a caratteri cubitali, sfrecciò sopra i cieli della capitale.
Marlene Dietrich era ormai la diva. Ma era anche una madre affettuosa – riferendosi a Maria disse “la mia unica ragione di vita” – così quando decise di tornare negli Stati Uniti portò la figlia con se. Rudi era, ovviamente, d’accordo. L’uomo dopo la partenza della moglie lasciò Berlino per trasferirsi a Parigi. Quindi andò negli USA per testimoniare a favore della moglie nella causa contro l’ex signora Sternberg. Sempre accompagnato da Tamara Matul, intima della stessa attrice ai tempi de L’angelo azzurro che, ormai, faceva di tutto pur di imitarla. Nevroticamente. Morirà pazza nel 1968 chiusa in un manicomio.
Tornando al cinema, nel 1931 Josef von Sternberg aveva diretto An American tragedy (Una tragedia americana), una critica alla società americana inizialmente pensata per Sergej Ėjzenštejn, che fu un discreto insuccesso. Il regista pareva non essere più in grado di dirigere senza Marlene e la Paramount era disposta ad assecondare l’eccentricità, la megalomania, i capricci di un artista sempre più innamorato della “sua creatura” nonostante la presenza di figlia e marito che venne, complice le sue benevole testimonianze nella causa di divorzio, assunto come aiuto regista. C’era qualcosa di “perverso”, ma il film successivo fu uno dei migliori della coppia. Il 12 aprile 1932 uscì Shanghai Express.

8. Shanghai Express (1932) di Josef von Sternberg
Nella lussuosa prima classe del treno Pechino-Shanghai, che attraversa la Cina sconvolta dalla guerra civile, viaggiano alcune persone considerate rispettabili, ma tutte hanno qualcosa da nascondere. La signora Haggerty (Louise Closser Hale) proprietaria di una pensione al femminile cerca di nascondere sul treno il suo barboncino; il maggiore Lenard (Émile Chautard) veste la divisa francese per non deludere gli affetti, ma è un disertore; Sam Salt (Eugene Pallette) commercia in diamanti rigorosamente falsi; Eric Baum (Gustav Von Seyffertitz) si fa passare per il proprietario di una miniera, ma in realtà è un trafficante di oppio; il reverendo Carmichael (Lawrence Grant) non nasconde la sua filosofia oscurantista e razzista; Henry Chang (Warner Oland) dai modi viscidi e misteriosi avverte sulla pericolosità della rivoluzione; il capitano e medico inglese Donald Harvey (Clive Brook) è incaricato di una missione segreta. Tra questi “rispettabili” anche due donne malfamate: la cortigiana cinese Hui Fei (Anna May Wong) e la famigerata mantenuta d’alto bordo Shanghai Lily (Marlene Dietrich), nota come il “fiore bianco della Cina” che vende le sue grazie lungo la costa del Paese. Le due donne vengono prima isolate, poi inutilmente desiderate dagli altri passeggeri. Shanghai Lily, veletta e collo di piume nere, è ovviamente notata dal maggiore Harvey che riconosce in lei Magdalen, la donna amata cinque anni prima (“C’è voluto ben più di un uomo a farmi cambiare nome in Shanghai Lily”). “Cinque anni e tre settimane” puntualizza lei facendo trapelare una passione mai sopita, ma soffocata dalle circostanze e dall’orgoglio. Il treno nel frattempo viene prima fermato dai soldati governativi, che catturano una spia ribelle, poi sequestrato dai rivoluzionari guidati da Chang che punisce gli altri viaggiatori della prima classe e prende in ostaggio Harvey dicendosi disposto a liberarlo solo in cambio della spia catturata. Le forze governative accettano, ma il ribelle minaccia ugualmente di accecarlo se Shanghai Lily non resta con lui. Il “fiore bianco della Cina” accetta per amore dell’ufficiale inglese, ma poco dopo Hue Fei entra nella stanza di Chang e lo uccide. Nella confusione tutti risalgono sul treno diretto a Shanghai. Tutti i “rispettabili” sembrano aver imparato qualcosa dalla vicenda fuorché Harvey che manifesta il totale dispresso per la sua vecchia fiamma, nonostante il reverendo Carmichael gli assicuri che la notte prima Lily aveva pregato per lui. Arrivati a Shanghai il maggiore inglese finalmente capisce.

9. la Cina, ritratta in maniera grottesca e caricaturale, chiese il ritiro della pellicola. Poi si piegò al fascino di Marlene
Il più grande successo commerciale della coppia Sternberg-Dietrich. Un melodramma esotico che una volta di più non aveva nulla di storico. La Cina, infatti, venne tratteggiata in maniera stereotipata e caricaturale, i rivoluzionari descritti come “una masnada di delinquenti”, seguendo le convenzioni cinematografiche dell’epoca che vedeva gli occidentali buoni e tutti gli altri cattivi. Il più grande Paese asiatico, ricostruito in studio, chiese il ritiro della pellicola, ma alla fine il fascino di Marlene prevalse anche su Mao.
Tutto nella pellicola era finalizzato a definire la bellezza sacrale dell’attrice. Per una volta protagoniste non furono le gambe, alle quali Sternberg concesse solo qualche allusione (il piede impantofolato che batte il tempo della musica che esce dal grammofono), ma il viso nobilitato dagli abiti di Travis Banton, la veletta, le piume nere, e magnificamente esaltato, in un gioco di luci e ombre, da Lee Garmes che si aggiudicò l’Oscar (nominati senza successo anche il film e il regista). A questo vanno aggiunte le straordinarie foto sul set di Don Elglish divenute iconiche; Freddie Mercury si fece ritrarre in una delle pose di Marlene e utilizzò lo scatto per promuovere la copertina del secondo album dei Queen.

10. Anna May Wong e Marlene Dietrich
La vita sentimentalmente libera di Marlene Dietrich correva parallelamente a quella cinematografica. Sul set di Shanghai Express si innamorò della collega Anna May Wong, la prima asiatico-americana a diventare una stella internazionale; poi ebbe una tormentata relazione con la scrittrice Mercedes de Acosta all’epoca impegnata con Greta Garbo. Amore che aumentò la tensione tra le due grandi attrici europee.
Ma questi continui flirt disturbavano Josef von Sternberg che già riteneva precario l’equilibrio raggiunto col marito Rudi. Durante le riprese di Shanghai Express ci furono i primi scontri che si accentuarono durante la lavorazione del successivo film con cui il regista voleva far a pezzi il mito che aveva costruito mostrando al pubblico che la sua venere era in realtà una donna sposata con prole, una “casalinga” infedele. Nacque su soggetto dello stesso Sterberg Blonde Venus (Venere bionda).
Oltre al clima venutosi a creare tra cineasta e musa ispiratrice, la lavorazione del film fu particolarmente drammatica. Marlene Dietrich, all’epoca la stella più pagata a Hollywood, ricevette, infatti, una lettera anonima che conteneva la minaccia di rapimento della figlia Maria. La questione si risolse positivamente, ma quella minaccia si inserì anche nel difficile rapporto madre-figlia (come scriverà anni dopo Maria Riva nella biografia di Marlene). Nonostante tutto le riprese si svolsero regolarmente dal 26 maggio all’11 giugno 1932. Nel cast anche un’allora semisconosciuto “belloccio” che farà una discreta carriera. Per l’anagrafe si chiamava Archibald Alexander Leach, ma il mondo lo ricorda come Cary Grant. Il 16 settembre Blonde Venus uscì nelle sale.

11. Venere bionda (1932) di Josef von Sternberg
Il chimico americano Edward Faraday (Herbert Marshall) conosce Helen (Marlene Dietrich), una bella cantante di night-club tedesca, mentre fa il bagno nuda in un lago di montagna, se ne innamora, la sposa e si trasferisce con lei negli Stati Uniti. Il matrimonio felice è arricchito dalla nascita di Johnny (Dickie Moore), ma Edward viene contaminato da delle radiazioni e rischia la vita se non torna in Germania a curarsi. Per procurare il denaro necessario Helen decide così di tornare ad esibirsi nei night-club. Col nome d’arte di Helen Jones ottiene grande successo e conquista il cuore di un ricco playboy, Nick Townsend (Cary Grant), che conosciuto il suo problema le offre l’aiuto finanziario e un appartamento per lei e per il figlio. Edward riesce ad andare in Europa per curarsi, ma una volta tornato non trova ne la moglie ne il figlio ad attenderlo. Scoperto il tradimento cerca di riavere il bambino. La donna scappa di città in città. Costretta, infine, a separarsi dal figlio, dopo una discesa verso l’abisso, Helen torna ad esibirsi questa volta a Parigi, con un elegante frac bianco (speculare a quello nero in Marocco). Il successo è quello di un tempo. Ritrova Nick, ma l’unico suo sogno è riabbracciare il figlio.

12. la celebre “Wodoo dance”
Una trama più solida rispetto alle precedenti con momenti, per l’epoca e non solo, di grande sensualità dal bagno tra i monti iniziali all’iconica “Wodoo dance” o “Gorilla dance”, rifatta anni dopo da Uma Thurman, in cui l’attrice spunta dal costume animalesco. La storia di una femme fatale con famiglia era la realtà e l’amante, nel film come nella vita, scelse di ritirarsi nell’ombra.
Von Sternberg maturò, infatti, la decisione di prendersi una pausa da Hollywood e da Marlene per andare Berlino, riallacciare i rapporti con l’UFA e trovare nuova ispirazione artistica. Peccato fosse ebreo, nel gennaio del 1933 con Hitler appena salito al potere.
La cultura della Repubblica di Weimar, venne cancellata. Decine di artisti costretti ad emigrare, altri uccisi (sorte che toccherà anche a Kurt Gerron e Karl Huszár-Puffy che Sternberg aveva diretto ne L’angelo azzurro). Il regista avevo un amico in Germania, Emil Jannings, ma era diventato il divo più adulato del Terzo Reich. Ripartì subito in fretta e furia per Hollywood.
Nel frattempo Marlene Dietrich, utilizzando la clausola del contratto con la Paramount che le consentiva la scelta del regista, aveva reclutato per il successivo film Rouben Mamoulian regista di origine armena che due anni prima aveva diretto Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Il dottor Jekyll), forse la migliore trasposizione cinematografica del romanzo gotico di Robert Louis Stevenson.
Il soggetto su cui la Paramount stava lavorando era, invece, tratto da un romantico racconto di Hermann Sudermann già alla base di Sunrise: A Song of Two Humans (Aurora) di Friedrich Wilhelm Murnau. Il 19 luglio 1933 uscì The Song of Songs (Il cantico dei cantici).

13. Il cantico dei cantici (1933) di Rouben Mamoulian
Rimasta orfana, l’affascinante contadina tedesca Lily Czepanek (Marlene Dietrich) va a lavorare nella libreria della severa zia (Alison Skipworth). In quel luogo di cultura conosce per caso lo scultore Richard Waldow (Brian Aherne) che la vuole come modella. Posa così nuda per lui, si innamora ma, per colpa di una serie di equivoci, è costretta a sposare il rozzo Barone von Merzbach (Lionel Atwill). Solo quando Lily avrà il coraggio di distruggere la sua immagine, cioè la statua con le sue sembianze, i due amanti, che conoscono a memoria il “Cantico dei cantici”, potranno riabbracciarsi.
Il film, che oscilla un po’ confusamente tra commedia e dramma, ha punte di erotismo importanti, Marlene nuda coperta solo dal gesso, gli abiti disegnati dal solito Trevis Banton, e un finale metaforicamente perfetto: l’attrice distrugge la sua immagine. Delle statua rimarranno integre solo le gambe che Marlene Dietrich, ben prima di Cristiano Ronaldo, aveva fatto assicurare.
Non il suo miglior film, ma Mamoulian riuscì a fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima o farà dopo: dirigere nello stesso anno Marlene Dietrich e Greta Garbo. Pochi mesi dopo, infatti, il regista firmò per la MGM Queen Christina (La regina Cristina) con la diva svedese al massimo del successo.

14. Rouben Mamoulian fu l’unico regista a dirigere nelo stesso anno Marlene e Greta, qua nei panni della Regina Cristina
Ma se la Metro-Goldwyn-Mayer aveva fatto un film su una regina, la Paramount poteva non rispondere? Dopo liti, rancori, incomprensioni, passioni nel maggio del 1933 Josef von Sternberg e Marlene Dietrich firmarono un nuovo contratto per la realizzazione di due film. Il primo era incentrato su Caterina, l’imperatrice di tutte le Russie.
Lasciando al regista lo sviluppo della sceneggiatura, Marlene, pochi giorni dopo la firma del contratto, partì con la figlia Maria e il marito Rudolf sul transatlantico “Europa” alla volta del vecchio continente. Due le tappe previste: Parigi e Vienna.
In Francia, nonostante venga fermata per essere scesa in abiti maschili, si sente come a casa. Ama fin da subito la lingua, che già conosceva, la cultura, l’atmosfera. Riabbraccia Friedrich Hollaender, scappato dal regime nazista, e con lui, per la Polydor, incide nuove canzoni. Poi feste, incontri, ricevimenti. Se quello in Germania era stato un viaggio “privato”, quello a Parigi fu un viaggio “ufficiale”.
In uno degli incontri venne avvicinata dal barone Welczeck che la “invitò” in ambasciata. Già, perché il “barone” era l’ambasciatore nazista a Parigi. Con la scusa-ricatto del rinnovo del passaporto, e ben informato sul contratto scaduto per la Paramount (la notizia del rinnovo in Europa non era ancora giunta), Welczeck le propose un accordo esclusivo con “libertà” sulla scelta dei soggetti e dei registi alla cifra stratosferica di 250000 marchi a film. Tutto purché diventi la cittadina più prestigiosa del Terzo Reich.

14. a Marlene Dietrich venne proposto di rappresentare il Nazismo
Con figlia e marito ad attenderla nei corridoi probabilmente non fu facile, ma Marlene richiamò il suo rapporto lavorativo con von Sternberg e al gelo che si creò commentò: “Devo intendere che rifiutereste al signor von Sternberg di girare un film nel vostro Paese (dissi proprio vostro Paese) perché è ebreo?”.
Dopo aver faticosamente ottenuto il passaporto Marlene e la famiglia partirono per Vienna, in una visita meno “intensa” rispetto a quella parigina, ma emotivamente significativa: era la città che aveva dato i natali al suo mentore.
Marlene Dietrich tornò negli Stati Uniti alla fine del 1933, con un’altra serie memorabili di foto in abiti maschili, in tempo per le riprese del nuovo film. Josef von Sternberg, nel frattempo, aveva terminato insieme allo sceneggiatore Manuel Komroff la preparazione del film. Il 15 settembre del 1934 uscì The Scarlet Empress (L’Imperatrice Caterina).
Fin dall’infanzia, la principessa tedesca Sofia Federica (Maria Elisabeth Sieber, la figlia di Marlene) è destinata a diventare regina ed educata a questo scopo con severità. In età adulta (Marlene Dietrich) la giovane riceve la visita del conte Alessio (John Davis Lodge), un bellissimo messaggero della corte Russia, incaricato di portarla in sposa al Granduca Pietro (Sam Jaffe), erede al trono. Giunta nell’immensa e imponente corte di Pietroburgo e ribattezzata Caterina dalla dispotica imperatrice Elisabetta (Louise Dresser), scopre che il futuro zar e marito è un ometto psicopatico e intantile, che la sposa per dovere, ma la trascura per i suoi folli passatempi e la compagnia della corrotta contessa Elisabetta (Ruthelma Stevens). In una fitta serie di umiliazioni, tradimenti e intrighi di potere Sofia Federica saprà trasformarsi da ragazza innocente a spietata donna di Stato che fa uccidere il marito per salire al trono col nome di Caterina II, imperatrice di tutte le Russie.

15. L’Imperatrice Caterina (1934) di Josef von Sternberg
Sontuosa ricostruzione storica di Sternberg, che ispirò anche l’amico Ėjzenštejn per il suo Ivan il terribile, animata dall’eros. Indimenticabile Marlene Dietrich che tiene una candela in mano durante il matrimonio, con un esplicito riferimento sessuale, o il banchetto nuziale.
Nel film von Sternberg scelse di cancellare il mito che egli aveva stesso contribuito a creare togliendo all’attrice due aspetti in cui primeggiava: il canto e le gambe. La pellicola, bellissima e indimenticabile, fu, forse anche per questo, un clamoroso insuccesso commerciale, dato che portò alla marginalità del produttore Schulberg, colui che aveva sempre dato la classica “carta bianca” al regista, e il direttore della Paramount divenne Ernst Lubitsch, altro europeo emigrato negli USA, maestro delle commedie che non amava troppo gli eccessi, produttivi e narrativi, del collega.
Ma per la coppia Sternberg-Dietrich il contratto prevedeva ancora un film. Il cineasta scelse di adattare, quasi a chiudere un cerchio, il racconto “La femme et le pantin” (“La donna e il burattino”) del francese Pierre Louÿs, storia, ovviamente, di una donna contesa tra due uomini. Voleva intitolare la pellicola Caprice Espagnol, ma Lubitsch gli impose un altro titolo. Il regista fu costretto ad accettare. In fondo tutti sapevano che quello sarebbe stato l’ultimo film insieme. Il 15 marzo del 1935 uscì The Devil Is a Woman (Capriccio spagnolo).

16. Capriccio spagnolo (1934) di Josef von Sternberg
Durante il carnevale di Siviglia la bellissima Concha Perez (Marlene Dietrich) fa perdere la testa all’esule politico Antonio Galvan (Cesar Romero). In attesa del fatidico appuntamento, quest’ultimo incontra il vecchio commilitone Don Pasqual (Lionel Atwill) e scopre che anche l’amico è innamorato della donna, nonostante sia stato più volte fregato dalla stessa e dalla madre la señora Perez (Alison Skipworth). Finiscono inevitabilmente per sfidarsi a duello, con Concha che promette di scappare con il vincitore, per poi decidere a modo suo.
Un melodramma realizzato grazie al ripetuto uso del flashback, Don Pasqual rievoca in sette momenti la sua storia con Concha Perez, con Marlene “mangiatrice di uomini” come non mai, fredda, avida, calcolatrice, ma la “visione del mondo è lucida e tutt’altro che frivola: tra le persone vige la corruzione, a cui non rinunciano neanche le forze dell’ordine” (Mereghetti) e per questo il film venne censurato in Spagna fino al 1959. Scarsi i risultati al botteghino.
Fu il settimo e ultimo film della coppia Sternberg-Dietrich, il più amato da Marlene. Fu il regista a tagliare definitivamente ogni rapporto personale e professionale con l’attrice, ma senza la sua musa, e osteggiato dai produttori come era successo ad un altro von (Stroheim), non riuscì più a ritrovare quel cinema eccessivo, ridondante, barocco, irreale che lo portò a lasciare un segno indimenticabile a Hollywood. Del dopo Dietrich da ricordare The Shanghai Gesture (I misteri di Shanghai, 1941), Macao (L’avventuriero di Macao, 1952), The Saga of Anatahan (L’isola della donna contesa, 1953), dalle consuete ambientazioni esotiche interamente ricostruite in studio. Josef von Sternberg morì a Hollywood il 22 dicembre 1969.

17. Josef von Sternberg e Marlene Dietrich sul set di Disonorata
Il più felice della rottura tra Sternberg e Dietrich fu Lubitsch che, liberatosi del rivale, era sicuro di trovare alla Paramount decine di registi in grado di sfruttare, sebbene in film dalla sensualità meno marcata, la naturale carica erotica di Marlene.
Il primo a dirigerla nel dopo Sternberg fu Frank Borzage, all’anagrafe Francesco Borzaga, regista di chiarissime origini italiane, maestro delle commedie sentimentali con all’attivo due Oscar (per Settimo cielo e Bad Girl) che, con la supervisione di Lubitsch, decise di ridefinire l’immagine stessa della diva partendo da un ruolo, quello di una ladra di gioielli, che aveva già interpretato in Germania, da una cornice esotica che aveva già attraversato, la Spagna di Capriccio spagnolo, e da un partner che aveva già avuto (in tutti i sensi). L’attrice avrebbe voluto John Gilbert, attore tra i più popolari ai tempi del muto, ma soprattutto amante della rivale Greta Garbo, la scelta, tuttavia, cadde su Gary Cooper già al suo fianco in Marocco. Quando Gilbert venne trovato morto a seguito di un infarto nella sua casa di Bel Air, Marlene provò uno straziante senso di colpa. Le musiche, su espressa richiesta di Dietrich, furono curate dall’amico Frederick Hollander. L’11 aprile del 1936 uscì Desire (Desiderio o Canaglie di lusso).

18. Desiderio (1936) di Frank Borzage
Dopo aver rubato a Parigi una preziosa collana di gioielli, Madeleine De Beaupre (Marlene Dietrich) fugge in Spagna usando l’ingenuo ingegnere americano in vacanza, Tom Bradley (Gary Cooper), per nascondere alla dogana la refurtiva. L’uomo se ne innamora perdutamente, ma quando il complice Carlos Margoli (John Halliday) e la zia Olga (Zeffie Tilbury) cercano di recuperare i gioielli e sbarazzarsi dello scomodo testimone, Madeleine saprà da che parte schierarsi.
Una commedia degli equivoci, nello stile di Borzage e di Lubitsch, che ottenne un grande successo di pubblico. Due le scene da ricordare: la fuga in auto nella prima parte e il corteggiamento nel castello nella seconda. I vestiti di Marlene vennero firmati, una volta di più, da Travis Banton, mentre i gioielli, che la protagonista accarezza sensualmente nei titoli di testa, erano di Eugene Joseff che produrrà in futuro quelli per Vivien Leigh in Via col vento ed Elizabeth Taylor in Cleopatra.
Sempre nel 1936 e sempre per la Paramount Marlene Dietrich partecipò a I Loved a Soldier (Ho amato un soldato) diretto da Henry Hathaway, film incompiuto e perduto, per poi essere scritturata dalla United Arsist per The Garden of Allah (Il giardino di Allah, Anime nel deserto o Il giardino dell’oblio) diretto dall’anticomunista Richard Boleslawski.

19. Il giardino di Allah (1936) di Richard Boleslawski
Monica (Marlene Dietrich), una giovane e ricca donna francese, viaggia nel deserto algerino, chiamato dagli arabi Il giardino di Allah, per ritrovare se stessa. Tra le dune trova, invece, Boris (Charles Boyer), se ne innamora, ma l’uomo è un monaco trappista che non ha rinunciato ai suoi voti.
Girato nel deserto dell’Arizona per sperimentare il technicolor, questa modesta pellicola ha un indubbio merito: aver fatto vedere per la prima volta Marlene Dietrich a colori.
Sempre per l’United Artists nel 1937 l’attrice accettò di girare a Londra Knight Without Armour (L’ultimo treno da Mosca o La contessa Alessandra) diretto dal grande Jacques Feyder.
Nella Russia del 1917 il giornalista inglese Ainsley J. Fothergill (Robert Donat) si unisce ai bolscevichi sotto falso nome, quello di Peter Ouronov. Dopo un attentato che uccide un ministro zarista, cerca di salvare la figlia, la contessa Alessandra Vladinoff (Marlene Dietrich), ma viene arrestato dall’Armata bianca. Riuscirà a fuggire e si ricongiungerà con la nobile grazie ad un bolscevico dal cuore d’oro e alla Croce Rossa.
Un melodramma avventuroso con una ricostruzione di quel clima resa possibile grazie alla passione di Feyder per i film sovietici. La Rivoluzione d’Ottobre fu altro, ma Marlene che fa il bagno dopo essere scappata dai bolscevichi non si dimentica.

20. L’ultimo treno da Mosca (1937) di Jacques Feyder
Così come rimane difficilmente dimenticabile il fatto che l’attrice devolse l’intero cachet del film, 450000 dollari, per le donne e gli uomini in fuga dalla Germania. Marlene era orgogliosa di essere tedesca, sottolineava ironicamente “grazie a Dio sono nata in Germania”, ma non voleva avere nulla a che fare col Nazismo. Nemmeno con Emil Jannings, col quale aveva lavorato ne L’angelo azzurro, ricordato dalla diva come “detestabile prosciutto”.
Adolf Hitler, al contrario, non si rassegnava all’idea di averla persa. Il Führer, nemmeno troppo segretamente, si era innamorato della femme fatale, chiedeva la proiezione privata dei suoi film, e confidava di annoverarla tra le sue amanti. Incaricò Goebbels di convincerla, con le buone o con le cattive, a diventare il volto del Nazismo.
Durante il soggiorno a Londra Marlene Dietrich venne così contattata da Joachim von Ribbentrop, Ministro del Reich per gli affari esteri noto anche per aver firmato con Molotov il patto di non belligeranza con l’URSS, che le propose nuovamente un incarico milionario con l’UFA, ormai al servizio del regime. La risposta fu ancora una volta negativa.

21. Adolf Hitler era innamorato di Marlene Dietrich
La dittatura ripiegò così su Leni Riefenstahl prima, già seconda scelta dopo Marlene ai tempi de L’angelo azzurro, e su una serie di mediocri attrici dopo. Tra queste Zarah Leander, modellata con risultati grotteschi come l’anti-Dietrich, Kristina Söderbaum, protagonista del film nazista per antonomasia Süss l’ebreo e Lída Baarová l’amante di Goebbels. Tutte ariane, ma non di origini tedesche e, soprattutto, parola del Führer “nessuna è brava quanto lei”.
Molti artisti furono costretti a lasciare la Germania, lei scelse di lasciarla. Rientrata negli USA Marlene Dietrich prese la cittadinanza statunitense rinunciando a quella tedesca. Era il 6 marzo del 1937 (votò per la prima volta nel 1939). Hitler in persona scatenò contro l’attrice una violenta campagna denigratoria. Venne additata come “traditrice della Patria”.
Fortunatamente ad Hollywood ad aspettarla c’era Lubitsch, bandito dal regime in quanto ebreo (finirà anche nel famigerato documentario L’ebreo errante), che dopo aver supervisionato Desiderio, scelse di dirigerla in un nuovo film della Paramount. Il 29 ottobre del 1937 uscì Angel (Angelo).
Anthony Halton (Melvyn Douglas) incontra a Parigi nella lussuosa “maison” della granduchessa Anna Dmitrievna (Laura Hope Crews) una donna dal passato misterioso che ribattezza Angelo (Marlene Dietrich). In realtà la donna è Maria Barker moglie trascurata dell’abile diplomatico inglese Sir Frederick Barker (Herbert Marshall). Il caso porta i due, dopo una splendida serata alla fine della quale la donna sparisce nel nulla, a ritrovarsi nella casa dei Baker. Fanno finta di non conoscersi per poi ritrovarsi tutti e tre, tra invidie e sospetti, nella “maison” parigina. Sarà lei a decidere.

22. Angelo (1937) di Ernst Lubitsch
Usando un tradizionalissimo triangolo sentimentale, Lubitsch diresse “uno dei suoi film più misteriosi e magistrali” (Mereghetti) evitando di raccontare sentimenti e azioni, spesso celate da inquadrature che mostrano altro. Un capolavoro, ma il film fu un insuccesso al botteghino. La Paramount rescisse il contratto con Marlene che era passata dall’essere “fatale” con Sterberg ad essere “umana”. Come se non bastasse Lubitsch, grandissimo, ma cinico come pochi, passò alla MGM per dirigere la rivale Greta Garbo nell’indimenticabile Ninotchka.
L’attrice, che rimarrà comunque grata al regista, decise di staccare e partire una volta di più per l’Europa. Tra la fine del 1937 e i primi mesi del 1938 viaggiò tra Parigi, Salisburgo, Austria, Svizzera, dove studiava la figlia Maria. Poi a Venezia, alla Mostra del cinema, dove riabbracciò Sternberg e conobbe lo scrittore Erich Maria Remarque, esule come lei, inviso al regime nazista che lo accusava di disfattismo i suoi romanzi, su tutti “Im Westen nichts Neues” conosciuto in Italia col titolo “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Avevano troppo in comune perché non succedesse niente. Fu un amore tormentato di cui ci rimane poco anche perché la terza moglie dello scrittore, l’attrice Paulette Goddard, distrusse la fitta corrispondenza amorosa.
Quindi Marlene andò in Costa azzurra dove ebbe un’altra relazione, questa volta con Joseph P. Kennedy attore, diplomatico nonché padre di John Fitzgerald con quale, la femme fatale per eccellenza, avrà una notte di passione nell’autunno 1962 quando JFK era il Presidente degli Stati Uniti.

23. Jean Gabin
Tornando al cinema l’amata Francia sta vivendo la stagione del realismo poetico e c’era un soggetto che pareva scritto per Marlene: Dédée d’Anvers. La storia raccontava gli intrecci di una cantante di cabaret, Dédée, un protettore tirannico e due amici che si contendono l’amore della donna. Uno, per amore della sua fatale bellezza, ucciderà l’altro. L’uomo che avrebbe interpretato il malinconico perdente aveva già un nome ed era divenuto il volto di quella corrente cinematografica, si chiamava Jean Gabin. Fu un grande amore, ma stava per scoppiare la guerra e il film non si fece.
Ancora in Francia Marlene ricevette una telefonata dal Direttore di produzione della Universal, Joe Pasternak, che le offrì un nuovo film a Hollywood in sostituzione di, ironia della sorte, Paulette Goddard, all’epoca compagna e attrice di Charlie Chaplin. I venti di guerra erano sempre più forti e l’attrice accettò.
La regia era stata affidata George Marshall, che aveva iniziato col muto e finirà con Jerry Lewis; il protagonista maschile era, invece, un giovane attore in uno dei suoi primi ruoli importanti, James Stewart. Il 29 dicembre 1939 uscì Destry Rides Again (Partita d’azzardo).

24. Partita d’azzardo (1939) di George Marshall
La cittadina di Bottleneck nel profondo West è in preda alla banda del baro Kent (Brian Donlevy) che truffa poveri malcapitati grazie alla complicità dell’affascinante Frenchy (Marlene Dietrich) che gestisce il chiassoso saloon. Kent dopo aver ucciso lo sceriffo, indica come successore l’ubriacone del paese Wash (Charles Winninger), ma quest’ultimo prende sul serio il ruolo e nomina come suo vice Tom Destry (James Stewart), figlio di uno storico sceriffo, che non vuole usare armi, ma finisce per sgominare la banda e conquistare il cuore della donna, pronta al sacrificio pur di salvarlo.
Un western, il primo per James Stewart e Marlene Dietrich, capace di unire elementi comici, melodrammatici e fasi da musical, le canzoni una volta di più erano state scritte da Friedrich Hollaender, su tutte “Little Joe The Wrangler”, grazie al quale emerse anche il lato comico dell’attrice.
La pellicola fu un grande successo e portò Marlene a realizzare due nuovi film con la Universal. Il primo venne affidato a Tay Garnett, uno specialista degli intrighi passionali, che nel dopo guerra dirigerà il suo film più famoso, The Postman Always Rings Twice (Il postino suona sempre due volte) con John Garfield e Lana Turner. Come coprotagonista venne ingaggiato John Wayne, fresco del successo di Stagecoach (Ombre rosse). Il 20 ottobre 1940 le sale americane proiettarono per la prima volta Seven Sinners (La taverna dei sette peccati).

25. La taverna dei sette peccati (1940) di Tay Garnett
La cantante di cabaret Bijou (Marlene Dietrich) provoca risse e tumulti ovunque si esibisca. Per questo viene espulsa da un’isola dei mari del sud insieme alle sue insolite “guardie del corpo”, il nerboruto Little Ned (Broderick Crawford) e l’illusionista Sasha (Mischa Auer). Sulla nave che porta “i rifiuti della società” in una nuova isola si fa notare dallo scorbutico medico di bordo Martin (Albert Dekker) poi, una volta a terra e tornata ad esibirsi nel vecchio locale, fa innamorare il tenente Dan Brent (John Wayne) che, dopo una scazzotata epica con gli uomini del losco Antro (Oscar Homolka), vecchia conoscenza della donna, dovrà scegliere tra amore e carriera.
Una commedia con un finale “triste” che racconta la solitudine di una donna indipendente in un mondo maschile e maschilista. Marlene, nel film, ritrovò il canto (indimenticabile la canzone “The Man’s in the Navy”), la seduzione e gli abiti maschili. E trovò anche una relazione con John Wayne.
Per il terzo film di Marlene alla Universal, il produttore Joe Pasternak calò, dopo Stewart e Wayne, un nuovo asso. Questa volta non l’attore protagonista, il modesto Bruce Cabot, ma il regista. Un grande cineasta francese in fuga dalla Francia occupata, tra i massimi interpreti delle avanguardie, René Clair. Il 24 aprile 1941 uscì The Flame of New Orleans (L’ammaliatrice).

26. L’ammaliatrice (1941) di René Clair
Lili (Marlene Dietrich), una donna dal dubbio passato, trasferitasi da San Pietroburgo a New Orleans, si spaccia per la contessa Claire Ledeux, cerca di sposare il vecchio e ricco Charles Giraud (Roland Young), ma quando il matrimonio è imminente cede alla passione per il capitano di battello Robert Latour (Bruce Cabot) e fugge con lui lungo il Missisipi.
Raccontato attraverso un lungo flashback, il primo dei quattro film girati da Clair negli USA è una commedia degli equivoci, ma “il compromesso raggiunto tra il suo stile e la presenza della diva finisce per scontentare tutti” (Mereghetti). Inscindibile, infatti, la diva virtuosa da quella peccaminosa. Marlene era e sarà sempre tutte e due. Fu un fiasco clamoroso.
Ma Clair, che si rifarà alla grande con film quali I Married a Witch (Ho sposato una strega) e And Then There Were None (Dieci piccoli indiani), non era l’unico artista in fuga dalla Francia occupata dai nazisti. Tra questi c’era anche colui che con gelosia mista a disprezzo Erich Maria Remarque chiamava “il ciclista” per sottolineare le sue origini proletarie. A Hollywood era arrivato anche Jean Gabin che aveva firmato un infruttuoso contratto con la 20th Century Fox.

27. I cacciatori dell’oro, (1942) di Ray Enright
Marlene lo accolse nella sua casa, si prese cura di lui e lo amò come solo lei sapeva fare, anche quando Gabin decise di rientrare in Europa, sempre più sotto la minaccia nazista, per combattere tra le fila delle Forces françaises libres.
Marlene, che era tornata sul set per Manpower (Fulminati, 1941) di Raoul Walsh in una classica storia a tre con Edward G. Robinson e George Raft, che sul set vennero quasi alle mani per l’attrice (perché se sei una vera femme fatale lo sei anche nella realtà…), condivideva, infatti, la scelta di Gabin, anche perché l’11 dicembre 1941 gli Stati Uniti erano entrati in guerra.

27. Kismet (1944) di William Dieterle
Marlene Dietrich, recitò successivamente in The Lady Is Willing (La signora acconsente, 1942) diretto da Mitchell Leisen in cui interpreta una donna disposta ad un finto matrimonio pur di adottare un bambino abbandonato, The Spoilers (I cacciatori dell’oro, 1942) di Ray Enright e Pittsburgh (La febbre dell’oro nero, 1942) di Lewis Seiler, due western in cui la maggiore curiosità sta nel fatto che John Wayne e Randolph Scott si invertirono i ruoli (Wayne “buono” nel primo, “cattivo” nel secondo e viceversa) e in Kismet (1944) diretto da William Dieterle in fuga dal Nazismo, una storia da “mille e una notte” che si ricorda soprattutto perché l’attrice fu completamente dipinta d’oro. Ma questi film Marlene Dietrich li recitò con minore entusiasmo e trasporto. Il suo interesse era ormai un altro, aveva scelto di essere una, o meglio, La diva antinazista.
Finanziò l’Hollywood Canteen, la “cantina” fondata dal comunista John Garfield e da Bette Davis che offriva svago e divertimento ai militari in partenza per l’Europa e l’Hollywood Committee creato da Ernst Lubitsch per dare sostegno economico ai profughi tedeschi. Non solo. Grazie ad alcuni contatti, su tutti il comunista Otto Katz (negli Stati Uniti verrà accusato di essere una spia russa e che morirà perseguitato nella Cecoslovacchia stalinista), pagò personalmente a numerosi cittadini ebrei il viaggio verso gli Stati Uniti o la Gran Bretagna.

28. Marlene Dietrich e Rita Hayworth nella “cantina” di Hollywood
Marlene chiese, inoltre, ad Abe Lastfogel presidente della United Service Organizations (USO), l’organizzazione che aveva il compito di offrire assistenza artistica alle truppe, di essere inviata in tournée sui fronti di guerra. Una donna? Al fronte. Magari a cantare. Lastfogel, sorpreso dalla stessa offerta, inizialmente rifiutò, ma dovette presto capitolare di fronte alla determinazione di Marlene Dietrich.
L’attrice partì come volontaria civile il 14 aprile 1944 per esibirsi, fino alla fine del conflitto, in molti fronti di combattimento: Italia, a Napoli e in Sicilia in particolare, Francia, Belgio, Olanda Nordafrica – in Algeria ritrovò Jean Gabin e conobbe il generale Patton. Andò, inoltre, a portare conforto alle truppe alleate anche in Islanda e Groenlandia.
Non si risparmiò affrontando in prima persona la guerra, durante il bombardamento di Cassino finì in un campo minato con l’attore francese Jean-Pierre Aumont (noto per l’interpretazione in Hôtel du Nord al fianco di Arletty), si sottopose a trasferimenti massacranti, affrontò ogni tipo di clima. Ovunque e comunque per distribuire cibo ai militari, visitare i feriti (anche quelli tedeschi che chiedevano increduli “È lei la vera Marlene Dietrich?”) e regalare a tutti il suo sorriso e la sua calda e inimitabile voce.

29. Marlene Dietrich con i soldati in Francia
Centinaia e centinaia di spettacoli in cui Marlene rispolverò tutto il suo repertorio, dalla musica classica alle indimenticabili opere di Friedrich Hollaender, le più richieste erano “The boys in the backroom” da Partita d’azzardo che apriva gli spettacoli e “The Man’s in the Navy” tratta da La taverna dei sette peccati che tra i marines era praticamente d’obbligo, per aggiungere una nuova canzone.
Nel 1938 il compositore tedesco Norbert Schultze, vicino a Goebbels, già autore di marcette e inni graditi alla dittatura, aveva musicato una poesia intitolata “Das Mädchen unter der Laterne” (“La ragazza sotto la lanterna”) scritta nel 1915 dal soldato Hans Leip in procinto di partire per il fronte russo. Il testo raccontava la storia malinconica di un soldato che temeva di essere dimenticato e sognava di tornare dalla ragazza che stazionava sotto il lampione. Quella ragazza si chiamava Lili Marleen.
La prima a interpretarla fu la cantante tedesca Lale Andersen che la incise nel 1939. Ma “Lili Marleen”, come ormai era stata ribattezzata la canzone, passò del tutto inosservata fino a quando non venne irradiata prima tra le truppe tedesche nell’Africa di Rommel, poi dalla radio Soldatensender Belgrad, nella Jugoslavia occupata dai nazisti. Gli Alleati la censurarono perché tedesca, i nazisti, Goebbels su tutti, cercarono di proibirla criticandone il tono antipatriottico e disfattista. I militari scrissero lettere di protesta, Lale Andersen finì in disgrazia, ma la musica non poteva essere fermata anche perché c’era un’altra tedesca che i nazisti non potevano controllare.

30. “Lili Marleen” divenuto un inno contro la guerra grazie a Marlene Dietrich che la cantò in inglese e in tedesco
Marlene Dietrich, nel 1942, incise in inglese, per la traduzione di Tommie Connor, e in tedesco “Lili Marleen”. La cantò in tutti e suoi spettacoli, su palchi improvvisati, sui cofani delle jeep, all’interno di una fatiscente baracca, facendola diventare un inno contro la guerra, tradotto in decine di lingue (in Italia cantata anche da Milva), amatissimo dai soldati di ogni schieramento. Perché tutti avevano una Lili Marleen da cui tornare.
Negli anni successivi, se si escludono le poche già citate apparizioni a Hollywood, Marlene Dietrich rimase in Europa. Festeggiò coi soldati la Liberazione di Roma e quella dell’amata Parigi e, nel 1945, entrò, rigorosamente in abiti militari maschili che peraltro le stavano magnificamente, con le truppe del generale Patton in Germania. A chi le chiese il perché di un simile rischio, per lei che era stata additata da Hitler come “traditrice della Patria”, rispose “per decenza”.
Nella Berlino distrutta dalla guerra poté, finalmente, riabbracciare la madre Wilhelmina che il Nazismo aveva isolato, morirà nel successivo inverno, per poi vedere gli orrori dei campi di concentramento, trovare in quello di Bergen-Belsen la sorella Elizabeth, il marito George Hugo Will e il nipote, e scoprire che avevano collaborato coi nazisti, erano in quel campo perché gestivano il cinema dei gerarchi. Provvederà al loro sostentamento, la sorella maggiore morirà nel 1973, ma in futuro la diva dichiarerà di essere figlia unica.

31. Marlene Dietrich, la diva antinazista
Marlene Dietrich in quindici anni passò dalla Germania di Weimar ai successi a Hollywood, dalla rivalità con Greta Garbo agli amori tormentati, dall’essere l’icona della sensualità a divenire la diva antinazista. Anni intensi e incredibili con un unico rimpianto: non aver ucciso Hitler. Secondo alcune recenti ricostruzioni, infatti, Marlene chiese, senza ottenerlo, un incontro privato con Hitler, non per sedurlo o accettare la proposta di divenire l’immagine della dittatura, ma per ucciderlo. Da atea convinta ricorderà: “A causa di Hitler cambiai la mia opinione riguardo alla non esistenza del paradiso e dell’inferno; ma naturalmente soltanto in riferimento a quest’ultimo”.
redazionale
Bibliografia
“Marlene Dietrich. I piaceri dipinti” di Sergio Arecco – Le Mani
“Marlene Dietrich” a cura di Paul Duncan – Taschen
“Josef von Sternberg” di Giovanni Buttafava – Castoro
“Storia del cinema” di Gianni Rondolino – UTET
“Il Mereghetti. Dizionario dei film 2021” di Paolo Mereghetti – Baldini & Castoldi
Immagini tratte da: immagine in evidenza foto Screenshot di Marocco e Shanghai Express; foto 1, 2, 7, 17, 21, 31 da it.wikipedia.com; foto 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 Screenshot del film riportato in didascalia; foto 14 da www.flickr.com (licenza libera); foto 23 Screenshot di La grande illusione; foto 28, 29, 30 da en.wikipedia.com
Le immagini sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono riportate in questo articolo solo a titolo illustrativo.