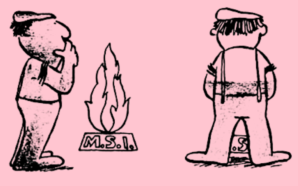Magari non sono cinquanta, ma ci si avvicinano. Le sfumature di grigio della sala dove si tiene il battesimo di “Articolo 1 – Democratici e progressisti” sono forse l’immagine migliore che descrive la sensazione che ho provato nell’ascoltare le parole di Roberto Speranza.
Almeno, quando a sinistra si facevano le scissioni serie (sia quella per antonomasia e storica del PCI dal PSI, sia quella più recente ma altrettanto imponente di Rifondazione Comunista nel 1991) si usavano teatri che venivano riempiti di rosso, di bandiere che avrebbero coperto pareti di palazzi per quanto srotolavano giù dalle quinte sui palchi.
Si cantava Bandiera rossa, l’Internazionale, si alzavano i pugni e ci si risentiva fedeli ad una idea di società che altri stavano abbandonando, che avevano in parte abbandonato nel ritenere impossibile la rivoluzione e, quindi, soltanto possibile un cammino riformista.
E la nobile parola “riformismo” divenne, da allora, stigma di tradimento, quanto meno di deviazione dal giusto, retto cammino rivoluzionario che a partire dal “Manifesto del Partito Comunista” di Marx ed Engels era venuto via via costruendosi insieme a staterelli neonati come l’Italietta cavouriana, assemblatrice delle regioni della Penisola dal Nord verso il Sud, assimilatrice di risorse e sfruttatrice di tanta povera gente che aveva sognato la libertà dal Borbone e dal papa re.
Oggi, in questo 2017 dove si riorganizzano gli assetti di rappresentanza politica del potere dei grandi ricchi di questo sciagurato Paese, le scissioni si fanno non salendo sul palco di un teatro, ma con un microfono in mano, da “giovani” e rivolgendosi ai giovani dicendo loro che il nuovo movimento che nasce dall’unione di due scissioni (Arturo Scotto da Sinistra Italiana, Roberto Speranza, Enrico Rossi, Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani dal PD) vuole rivolgersi a coloro che sono nati negli anni ’90 e che come simbolo adotta le parole dell’articolo uno della Costituzione repubblicana: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, eccetera, eccetera, eccetera.
Forse i giovani a cui i fondatori del movimento neonato per un nuovo centrosinistra vogliono rivolgersi non sanno che sino ad oggi le politiche antisociali costruite anno dopo anno, legislatura dopo legislatura dai governi che si sono succeduti hanno avuto l’appoggio di chi addita l’articolo uno della Carta come nuovo emblema di rilancio di una politica riformista.
Il Partito Democratico è stato ed è l’interprete fedele dei dettami liberisti che ci sono stati assegnati con lettere e con proclami dei ministri tedeschi e anche di primi ministri sia teutonici che d’Oltralpe e ha gestito la fase, non ancora esauritasi, della crisi economica non tutelando il lavoro ma privilegiando contrattazioni sempre meno garantite, parcellizzando i lavoratori, facendone dei moderni schiavi pagati in voucher.
Se davvero l’articolo uno, quindi la fondazione della Repubblica sul lavoro, fosse stato il fulcro dell’azione anche riformista di un certo centrosinistra, noi avremmo oggi in questo Paese una economia dove l’indice di riferimento per la così tanto decantata “crescita” starebbe nel tasso di occupazione stabile e con contratti collettivi nazionali e non nel tasso di incentivi statali alle imprese per finanziare i debiti dei padroni nati da speculazioni vergognose (eppure pur sempre tipiche del sistema capitalistico).
Se davvero l’articolo uno fosse oggi il riferimento di un movimento politico per il lavoro e per i giovani, questo movimento non dovrebbe puntare a ricreare il “centrosinistra”, ma la sinistra di alternativa, ossia quella che non intende avere il punto di vista del mercato come stella polare dell’equilibrio programmatico da definire bensì il punto di vista opposto, quello sociale, quello di ciò che un tempo con orgoglio si chiamava “socialismo” e che, poi, per non perdere definitivamente orgoglio e rappresentanza, i lavoratori, gli sfruttati hanno chiamato “comunismo”.
E’ successo così ovunque nel corso dei secoli: le socialdemocrazie, a parte i modelli scandinavi, sono state un lento logorio della sinistra e hanno aperto pericolosi varchi per le destre. La Germania nazista è un esempio di stato totalitario nato anche grazie alla disaffezione che i tedeschi, subissati da una terribile crisi di povertà, dal debito ingente della Grande guerra, avevano maturato nei confronti dei partiti democratici: dal Zentrum cattolico al Partito Socialista Democratico.
L’Italia fascista nasce quando si sommano i risentimenti nazionalisti della “vittoria mutilata” alla necessità dell’espansione di un capitalismo italiano proteso al colonialismo iniziato a fine ‘800, allo sfruttamento sempre più bieco di mano d’opera, passando per il cedimento socialista sull’iniziativa di pressione delle masse proletarie nei confronti della borghesia. La paura dei “rossi” stringe la classe dominante attorno ad un patto con il primo socialista che decide di operare una svolta a centottanta gradi.
Così accade ovunque la sinistra smette di essere veramente alternativa e lascia un varco aperto dove può generarsi il collegamento tra rabbia popolare per fame, povertà, diseguaglianze, paure del diverso (emigrazioni di inizio secolo…) e movimenti populisti pronti a raccogliere e sfruttare queste incertezze di larga misura.
Il modello del centrosinistra fondato sul Pentapartito aveva mostrato come tutto si reggesse sul legame stretto tra politica di palazzo ed economia della politica: governo e imprenditoria avevano un saldo legame fondato sulla difesa del privilegio reciproco.
Il centrosinistra degli ultimi anni ha avuto il sostegno morale del “voto utile” contro le destre: il pericolo del ritorno dei neofascisti ha prevalso su qualunque altra considerazione sociale. E se noi comunisti provavamo ad avanzare qualche richiesta di difesa del lavoro che mettesse in forse l’equilibrio precario delle coalizioni, eravamo subito messi all’indice di chi ci accusava di voler far tornare i fascisti al governo.
Sono rimasti così tanto persuasi e accecati da uno storico nemico da trasportare nel presente da non vedere che, aumentando il consenso popolare verso forze politiche di aperto sostegno al liberismo padronale, stavano creando tutti i presupposti per un nuovo fascismo, un nuovo autoritarismo non più vestito del fez e della camicia nera, ma fatto di grande finanza, di imprenditoria priva di qualunque scrupolo.
E in nome della “governabilità”, poi, di tutto questo splendido impianto di difesa dell’alfa e dell’omega, dei padroni e dei lavoratori (si fa per dire…), sono arrivati capi di stato e di governo a dirci che ciò che contava era la stabilità: ma non hanno mai detto per chi bisognava essere stabili, per quale motivo e cosa comportasse il contrario.
La povertà, era la risposta. Ma la povertà avanza proprio in virtù della governabilità e della stabilità che tanto hanno voluto i centrosinistra che si sono succeduti nel tempo e hanno ucciso la sinistra vera.
Oggi, pretendere di ridare al lavoro dignità passando per la ricostruzione di un terzo, quarto (ho perso il conto…) centrosinistra vuol dire andare a caccia dell’impossibile riunione tra mondo del profitto e dello sfruttamento e mondo del lavoro e della precarietà.
Sono due opposti le cui ragioni non possono essere simbiotizzate, rese avvicinabili nemmeno minimamente: o si sta con chi è sfruttato o con chi sfrutta.
Non si possono fare politiche sociali nel liberismo: così come sarebbe difficile fare politiche liberiste nel socialismo.
Ma non abbiamo la controprova. Noi sappiamo che è possibile, anche se – diciamo “filosoficamente” – impossibile, dare vita a governi che proteggono il profitto e i privilegi dei ricchi con il consenso dei poveri.
Questa è la contraddizione da spezzare! Con forza, senza più tentennamenti. Ci vorrà molto tempo? E sia! Ma non ricadiamo, per favore, nell’errore di illuderci che la “governabilità” di questo sistema produce miglioramenti per i poveri, per i moderni proletari, per tutti coloro che si aggiungono alla schiera sempre più numerosa di un pauperismo impressionante.
Quindi, si può dirsi ed essere “democratici” e anche “progressisti”, così come si può dire di essere “libertari, liberisti e liberali”: tutto nello stesso partito. Se riuscite a trovare un senso a tutto questo, filosoficamente parlando, accetto le lezione. Ma se non ci riuscite e mi venite a dire che il progressismo è provare a ridurre i danni del capitalismo, migliorando quotidianamente la vita dei poveri, io vi farò ora sempre una sola domanda: a che prezzo i poveri, i precari, i disoccupati, i lavoratori e le lavoratrici devono sottostare per vedersi concedere una elemosina di Stato a fronte dell’aumento sempre più esponenziale delle ricchezze dei padroni e della classe degli sfruttatori?
Vorrei conoscere la cifra. Vorrei che mi si dicesse quanto costa il compromesso. O la compromissione.
L’Articolo 1, declinato socialmente, non può che tradursi politicamente così oggi: “Il centrosinistra non può garantire gli interessi dei lavoratori”. E’ dimostrato. Basta guardarsi indietro anche di poco per non ripetere, senza fine, altri errori già ben noti e conosciuti.
MARCO SFERINI
26 febbraio 2017
foto tratta da Pixabay